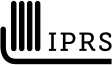La sapienza di Eros
Un contributo psicoanalitico per il “Viaggio alla scoperta della Giustizia Riparativa”
di Attilio Balestrieri e Raffaele Bracalenti
[Una sintesi di questo lavoro è stata pubblicata all’interno del volume Mannozzi G., Lodigiani G.A. (a cura di), Giustizia riparativa, il Mulino, Bologna 2015]
Difesa e relazione: il bisogno ineliminabile che la vita ha di difendersi e che la difesa ha di vivere
Ogni azione implica un portato di violenza, per molti versi ineludibile. Lo psicoanalista Sandro Gindro lo ricordava qualche volta, a noi allievi della sua scuola, ricorrendo a quest’esempio: di fronte all’immagine oleografica della rondine che con gesto affettuoso porta nel nido il nutrimento per i propri piccoli, non vi è commozione alcuna per il drammatico destino del verme catturato. E si può forse dire che tutto ciò che nasce e vive nasce e vive per un gesto d’amore, ma porta con sé anche qualcosa che è nel registro della violenza. Di questa violenza, che in psicoanalisi è stata definita “violenza fondamentale” [1], si vede il segno inequivocabile anche nel “legame atavico” [2] che con essa intrattiene il diritto.
La Restorative Justice (RJ), nel “problematizzare” [3] per l’appunto il legame atavico del diritto con la violenza, genera modalità di pensiero attivo e vigile, che dunque promuovono trasformazioni – come si usa dire in termini psicodinamici. Infatti, affermare che un portato di violenza è ineludibile, in qualsiasi intervento, azione o semplice gesto si compia, non significa certamente che la violenza debba essere accettata, né giustificata. Ed il dire che la violenza è ineludibile, al di là di qualsivoglia argomentazione etologica, nemmeno può autorizzare a considerare “naturale” la violenza, dunque ad evitare di “fare con essa i conti”, cioè a favorirne una frettolosa rimozione o un’ancor più pericolosa “scotomizzazione”. La violenza va rifiutata e dev’essere rifiutata proprio perché c’è, altrimenti non sarebbe nemmeno necessario problematizzare la questione di come rifiutarla.
La psicoanalisi, classicamente [4], invoca in proposito l’appello alla consapevolezza. L’armonia è una tensione tra opposti, ma non può nascere dalla distruttività, perché il bisogno pulsionale originario di tutto ciò che nasce e vive resta in ogni caso il desiderio primario dell’altro e verso l’altro. Per rifiutare la violenza, il primo passo è dunque assumerne l’ineludibilità: aver consapevolezza del rischio di violenza, implicito in qualsiasi azione. Rischio che ognuno è chiamato ad affrontare, nell’azione che decide di sé e del proprio futuro con gli altri. Ciascuno per sé, ciascuno per tutti. Questo dice la psicoanalisi e quest’assunzione di consapevolezza aiuta a cercare le vie meno violente, mentre si compie qualsiasi azione e qualsiasi gesto. In una ricerca in cui la verità è sempre oltre a mai altrove.
Curare la cura
Nel problematizzare il tema “diritto e violenza”, la RJ si appoggia ad una solida tradizione di pensiero [5], che molti riconducono ad un celebre passo di Pindaro [6] ed a cui anche la psicoanalisi ha molto contribuito [7]. Questa tradizione, nel mostrare che la violenza è all’origine del diritto, almeno nei suoi aspetti sottrattivo, aggiudicativo ed afflittivo/retributivo, dà anche inequivocabile evidenza di come il diritto riproduca la violenza ed in ultima analisi finisca per somigliare troppo all’oggetto che afferma di voler regolare, cioè la violenza stessa.
Cosa può dire di più la psicoanalisi su questo punto? Non già per chiarire l’intima connessione tra violenza e diritto, cioè il fatto per cui il diritto si fonda anche sulla violenza (non solo la violenza che conserva e mantiene in piedi il diritto, ma in primis la violenza che pone il diritto) che è tema già ampiamente evidenziato. Ma cosa può dire la psicoanalisi in merito al paradosso – ovvero l’enigma – che sottende tale assunzione?
Nemmeno il diritto, che pure nasce per l’appunto per gestire la violenza, sfugge all’ineludibilità della violenza, perché è anch’esso condannato a soggiacervi, fino a divenirne la mimesis. Non più antidoto ma acceleratore del contagio mimetico. Come dire che il diritto sancisce il fallimento di quel paradigma omeopatico della cura, basato sull’impiego di determinate quantità di sostanze che, essendo in grado di provocare effetti simili a quelli della malattia, dovrebbero attivare una reazione guaritrice da parte dell’organismo, in accordo con l’aforisma similia similibus curantur. Infatti, si può affermare che la violenza è il “farmaco omeopatico” utilizzato dal diritto per gestire la violenza.
Non è improprio – né del tutto irreverente, nonostante l’inevitabile ironia che ammanta questo discorso – parlare qui di cura, visto che la stessa RJ porta con sé, nell’aggettivo restorative che la qualifica, non solo il segno del ritrovamento di equilibri, ma senza dubbio anche quello della ricerca di un possibile “aver cura, o prendersi cura” della giustizia, oltre che del diritto. Restando dunque su questo piano allegorico, molto è stato detto sull’ambiguità del pharmakon: sostanza medicinale e ad un tempo venefica, rimedio che ammala mentre cura, medicamento che riproduce sofferenza [8]. È qui che la psicoanalisi – alleata stavolta della farmacologia – può ricordare come l’efficacia di qualsiasi farmaco in medicina – nel suo rivelarsi medicamento e non già tossico, ovvero più medicamentoso che tossico – si deve in ampia misura anche a quel quid ineffabile, che determina i parametri biologici, sebbene i parametri biologici non siano in grado di comprenderlo: il cosiddetto effetto placebo. Si tratta di un aspetto meno frequentato dalla riflessione sull’idea di pharmakon, che rimanda alla dimensione per così dire relazionale di quest’ultimo, in cui prende rilievo l’efficacia del medicamento “per simpatia”, ovvero in virtù di un effetto suggestivo. E la simpatia (nel senso etimologico di provare emozioni insieme ad un altro) così come la suggestione, richiamano l’attenzione sul discorso amoroso, cioè sulla questione dell’innamoramento. Se si vuole: sulla questione dell’efficacia dell’amore sulla cura, o della “cura per amore” [9].
Come dire che la cura funziona nella misura in cui produce e riproduce dinamiche di consenso, condivisione e riconoscimento reciproco. In ultima analisi: dinamiche d’innamoramento.
Se dunque il diritto non può garantire la scomparsa della violenza, in ragione dell’ineludibilità di quest’ultima, nemmeno il diritto riesce a minimizzarla, perché impone una cura – basata su quella farmacopea omeopatica di cui s’è detto – che non fa innamorare nessuno, ovvero che nessuno ama. Né coloro che amministrano la cura, né coloro che subiscono la violenza, né coloro che quella violenza mettono in atto, tantomeno la communitas.
In questa luce, la psicoanalisi può dire che la RJ, nel problematizzare il tema “diritto e violenza”, sebbene in complementarietà col diritto, si propone come giustizia (parliamo di giustizia riparativa non già di diritto riparativo) perché vuole aver cura e prendersi cura della giustizia, cioè vuole avvicinarsi alla verità della giustizia, nel tentativo di ricomprenderla nell’orizzonte dei rapporti umani. La RJ sogna una possibile giustizia e la sogna perché la desidera, come ne avesse una sorta di “nostalgia”. Per concretizzare quel sogno e realizzare il desiderio di cui quel sogno parla, la RJ individua il suo compito nel tentare di “curare la cura” ed accetta la sfida che quel compito implica, impegnandosi in una ricerca in cui la verità è sempre oltre e mai altrove.
La psicoanalisi può altresì aggiungere che vale curare la cura, perché la cura si è allontanata dalla sapienza di Eros, inteso come principio della buona cura. Questo nome la psicoanalisi lo prende in prestito dalla sensibilità dell’antica Grecia, per indicare un concetto mediante le forme incisivamente chiare di quel mondo di dèi. In accordo con Gindro: «Il vero si costruisce nella ricerca se la ricerca è una ricerca erotica. L’erotismo non riguarda soltanto il rapporto, più o meno fisico, fra le persone. Eros è un dio antico; Eros è un dio antichissimo. Un racconto lo dice nato dall’uovo deposto dalla Notte: dio primogenito dalle ali d’oro … il mito più antico lo vuole un dio della natura, che unisce e vivifica le cose; ma anche il primo dio che abbia fatto luce. Uscito dall’uovo d’argento, mostra le cose fino ad allora nascoste; mostra il cielo e la terra ed ecco perché fu anche chiamato Fanete. Sorto dalla Notte e dal Caos, Eros è il primo dio sapiente; fin da subito è il fine della sapienza. Ciò che è inizio e fine deve anche essere il mezzo e nel mezzo. “Eros io voglio cantare / il tenero Eros che brilla / di fiorite ghirlande / che i mortali soggioga / che anche agli dèi è re” (Anacreonte, Fr.28). Perciò la sapienza nasce con Eros, si conclude con Eros e si realizza attraverso Eros … Eros è il desiderio e la sessualità; la sessualità non ancora divenuta rito … l’atteggiamento erotico è quello che si dirige verso la verità senza timore; perché, senza timore, si dirige verso l’altro.» (A Tiresia, Psicoanalisi Contro, Roma 1983, p.31). La sfida di curare la cura, che la RJ accetta, ha dunque a che fare con la ricerca di Eros. Ma su questo argomento si tornerà nelle conclusioni.
Discorsi “a capo scoperto” [10]
La RJ accetta una sfida anche perché si propone un progetto ambizioso: quello di trovare un punto di sintesi di varie istanze, che concorrono a configurare lo scenario del diritto. Le principali sono tre: quella del condannato, quella della parte lesa e quella della società nel suo insieme (la communitas). E nel far ciò, la RJ accetta la sfida di confrontarsi con interessi in ampia misura confliggenti: quelli di una comunità che chiede sicurezza, quelli delle vittime che aspirano ad un’effettiva riparazione del danno subito e quelli dei condannati che lamentano l’inutilità dell’afflizione cui sono sottoposti. Si tratta in ciascun caso di persone che, anche al di là del loro scoprirsi – o coprirsi – nelle vesti di vittime o autori di reato, avanzano l’esigenza primaria di essere in quanto tali riconosciute. Avanzano cioè l’esigenza di esser pienamente riconosciute nella loro dignità di persone. Il tutto sullo sfondo di un’istanza generalizzata ancorché controversa, più o meno esplicita e consapevole, di dar senso – cioè spazi e confini, unitamente a contenuti che siano vincoli ed opportunità – ad un progetto sostenibile di communitas.
Non v’è dubbio che la detenzione è inumana e che il significato della pena viene in maniera crescente minacciato dall’evidenza della sua inutilità o peggio controproduttività [11] ai fini del recupero del reo ed ai fini dell’incremento della sicurezza “reale” di tutti, soprattutto quando il diritto riduce la pena misura esclusivamente afflittiva. Non v’è dubbio che l’inasprimento delle sanzioni, ancorché sempre più spesso richiesto dalla comunità tutta ed in primis dalle vittime di reato, ripara poco e restituisce loro ancor meno, soprattutto quando il diritto riduce quell’inasprimento a mera offerta del piatto freddo della vendetta. E non v’è dubbio che l’esigenza di maggior sicurezza, da parte della comunità tutta, sia parimenti meritevole d’attenzione, anche se si tratta di un’esigenza di sicurezza prevalentemente “interna”, come ampiamente dimostrato dai sociologi delle “società del rischio” [12] e come in parte accennato da Percamillo Davigo, nel suo contributo al film “Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa”. Sebbene la domanda di sicurezza avanzata dalla comunità e dall’opinione pubblica parli di “un’altra” insicurezza – in seguito a processi mentali di “condensazione” e “spostamento”, come si dice con linguaggio psicoanalitico – la RJ anche con questa domanda di sicurezza è chiamata a confrontarsi. La RJ è cioè chiamata a prendere in considerazione questa domanda nel suo significato “manifesto”, oltre che interpretarne il suo significato “latente”. Perché tutti – società, autori e vittime di reato – chiedono – e chiediamo – di esser riconosciuti nell’umanità di ciascuno. Ogni essere umano è persona e come tale domanda di esser kantianamente considerato come fine e mai come mezzo, seppur da prospettive diverse ed in relazione a diverse condizioni. Ed ecco perché la sfida è complessa ed il sovrapporsi dei piani, unitamente al sovente divergere degli interessi, possono dar luogo ad elementi di fragilità all’interno del sistema stesso della RJ.
Del resto, la RJ nasce dall’apporto di prospettive teoriche che hanno anche tradizioni diverse, che a loro volta si sono sviluppate anche sotto la spinta di diverse esigenze, da più parti avanzate: il rispetto dei diritti umani (forse il punto di sintesi) la vittimologia, la criminologia critica, l’antropologia giuridica, solo per citarne alcune. Ed anche dell’apporto di queste tradizioni e prospettive di pensiero la RJ si nutre. Il suo progetto è giustamente unico, perché una è la giustizia. Ma caso per caso è utile chiedersi – ovvero problematizzare – cosa si tenta di riparare, a chi si tenta di restituire e come. Beninteso: è anche questa ricchezza di significati che arricchisce il panorama della RJ, oltre che renderlo complesso. Alcuni esempi tornano utili per chiarire il senso del quesito qui sollevato.
Un’alternativa all’inutile
La questione dell’utilità o inutilità della pena è la meno controversa. Si parla di pena “alternativa” per addolcire il senso in sé terribile della pena, che è inoltre provvedimento in ampia misura inutile, vista anche la discutibilità del suo significato di minaccia, cioè di deterrent. Discutibilità ascrivibile non solo all’ancorché molto caldeggiato deficit di certezza della sanzione. Perché se almeno la pena servisse a qualcosa – sia ai fini del recupero di chi la espia, sia per riparare il danno subito dalla parte lesa dal reato, sia come monito per dissuadere altri dall’arrecare danno al prossimo – pur rimanendo terribile, conserverebbe un’utilità. Invece, oltre che esser inumana – soprattutto nella prospettiva del rispetto dei diritti umani, anche per le ben note ragioni che rendono troppo spesso insostenibile il regime detentivo – la pena serve solo a “perder tempo”, nel senso letterale di questo modo di dire. Non v’è dunque dubbio che la pena configura un’espressione del male assoluto. Da qui l’idea di flettere la pena su qualcosa di diverso dal suo fondamento meramente punitivo ed espiativo. Ed ecco il lavoro cosiddetto socialmente utile. Utile al recupero – attraverso un’attività ritenuta socialmente nobile – ed utile affinché il tempo non sia solo alienazione. La punizione diviene meno acerba e l’espiazione più funzionale. Permane per molti versi un portato di violenza, connesso a valenze moralistiche: la miglior cura è il lavoro, secondo il vecchio adagio per cui “il lavoro nobilita l’uomo”. Quale miglior occupazione se non il lavoro, per porre rimedio al vizio che minaccia gli sfaccendati! Dimenticando che il lavoro criminale è anch’esso un lavoro, che richiede impegno di risorse ed abilità. E se il lavoro è alienante, o come tale percepito, per evitare di “perder tempo” ben vengano allora le attività ludiche, creative ed espressive, nonostante il rischio che facilmente può dar loro uno scacco cocente: la cosiddetta “infantilizzazione”. Il problema resta quello di render sostenibile il trascorrere del tempo. D’altra parte, anche per i disoccupati sono previsti lavori socialmente utili, proprio per compensare il danno dovuto all’alienazione del tempo.
Nonostante ciò, il lavoro serve davvero, perché utilizzare il tempo di esecuzione della misura per compiere un percorso formativo, che non sia solo quello della professionalizzazione del lavoro criminale, contribuisce a creare i presupposti per un recupero sostenibile, in vista di un positivo reinserimento sociale. Grazie al lavoro socialmente utile – sia esso svolto a favore della comunità o nella prospettiva di un positivo inserimento o reinserimento nella società civile – l’esecuzione della pena non si traduce nella “cancellazione sociale” del “reo”, che viene invece riconosciuto come “persona”. E vi è in ciò un’analogia con uno dei principi basilari del “lavoro” psicoanalitico. Il “reo” agisce la pena e non solo la subisce, così come il superamento degli elementi problematici che conducono una persona a rivolgersi alla psicoterapia non può essere demandato a qualcun altro, perché il paziente – o meglio l’analizzando, come si dice oggi – è attore della cura e non già la subisce – diversamente da quanto tradizionalmente accade secondo il paradigma classico della medicina. La cura è tale nella misura in cui considera il proprio destinatario come persona. La cura prevede che il suo destinatario, in quanto persona, non sia solo “oggetto”, bensì “soggetto”, dunque centro ed attore partecipe del procedimento terapeutico.
È tuttavia utile richiamare qui l’attenzione su una sovrapposizione di dimensioni e significati. Il lavoro, nell’accezione di impegno nel partecipare attivamente ad un percorso di cambiamento, è utile al “reo”, che conserva – o riconquista – la propria dimensione di persona, per l’appunto in virtù di questo lavoro. Nell’accezione di “lavoro socialmente utile”, l’impegno in un percorso di cambiamento, se svolto attraverso un’attività lavorativa a favore di altri, torna anche a vantaggio dell’intera comunità civile. Visto complessivamente nella sua duplice accezione, questo lavoro “di coppia”, in cui il recupero del “reo” come persona viene a coincidere col benessere dell’intera società, implica altresì una “ricaduta positiva” anche sulla terza parte in causa: la cosiddetta “vittima”. Questa ricaduta ha tuttavia un valore soprattutto di testimonianza, alla stregua di una rassicurazione indiretta. Infatti, per la vittima del danno conseguente al reato, l’utilità del lavoro di cui si parla risiede principalmente nella rassicurazione in merito all’effettivo recupero dell’autore di quel reato, ottenuto in virtù di un percorso di ravvedimento e di un’attività socialmente utile. A meno che quel “lavoro” non implichi forme e modalità di risarcimento più dirette, con l’inevitabile rischio che ne deriverebbe. Cioè l’ovvio rischio di una nuova radicalizzazione delle dinamiche “private” di violenza/vendetta/faida [13].
In sintesi: il dibattito sull’utilità/inutilità della pena ha tentato a lungo di operare una sorta di “compromesso”, che è consistito nel voler flettere la pena su qualcosa di strutturalmente estraneo al suo stesso fondamento, che com’è noto risiede in un principio retributivo (rispondere al male col male) ed in un principio di proporzionalità (occhio per occhio, dente per dente). La RJ ha invece problematizzato quest’approccio e lo ha problematizzato radicalmente, rifuggendo la via di un compromesso impossibile: non già tentando di snaturare la pena (tentando cioè di trasformare la pena in ciò che non è e non può dunque diventare) bensì assumendone il vero significato e mettendone direttamente in discussione la validità. Come dire che non si dà la possibilità di individuare una “pena alternativa” ma “un’alternativa alla pena”, ovvero qualcosa di sostanzialmente e concettualmente diverso dalla pena. Ed è qui che il paradigma riparativo prende piena autonomia, differenziandosi da quello punitivo/retributivo – sebbene possa operare in complementarietà con esso.
È vero che la questione dell’utilità o inutilità della pena è la meno controversa, tra le molte che la RJ affronta. E la riparazione, quale vera alternativa all’inutilità della pena, più della pena dovrebbe rispondere anche alle esigenze della vittima. In particolare a quella profonda esigenza della vittima, che consiste nel veder riconosciuto che quanto accaduto (cioè il reato) unitamente a ciò che da quanto accaduto è derivato (ovvero il danno subito) rappresentano un’ingiustizia. Tuttavia, il condizionale “dovrebbe” è d’obbligo, perché proprio su questo punto – quasi paradossalmente – permane una “resistenza” (in senso squisitamente psicoanalitico) a prender le distanze dall’idea di pena. Ed è in virtù di quest’elemento di resistenza che la pena mantiene una sua utilità soprattutto per le vittime, nella misura in cui molte di queste persone, a livello individuale o a livello di soggetti della loro rappresentanza, restano ancora per molti versi “costrette” ad invocarla. Costrette non già dalla volontà di un preciso agente esterno ma dalla configurazione stessa del contesto del diritto. Come di seguito specificato.
Ancorché paradossale, questo fatto non può peraltro sorprendere. Infatti, nella logica stessa del diritto – e nel contesto del diritto – soprattutto la questione della pena è per così dire concettualmente “reocentrica”, cioè predisposta ad esser affrontata prevalentemente all’interno di una dialettica tra il reo ed il diritto stesso, da cui la vittima è messa da parte, per non dire esclusa. In parole molto semplici: chi sbaglia paga ed il prezzo è la pena, la cui gestione spetta però al diritto, che – per definizione – la sottrae alla vittima. E non sorprende pertanto che il dibattito sulla pena tenda “naturalmente” a problematizzare il significato e l’utilità della pena privilegiando il vertice della responsabilità del diritto – ed il vertice della responsabilità sociale – nei confronti del reo. È chiaro che l’alternativa alla pena, a patto di sostenere l’impegno che quest’alternativa richiede, dischiude una chiara alternativa alla “cancellazione” personale e sociale del reo. Appare invece meno chiara l’alternativa che l’alternativa alla semplice punizione del reo concretamente dischiude per la vittima. Perché minore è l’impatto che l’alternativa alla pena immediatamente prefigura a vantaggio degli interessi della vittima, in mancanza di altri incentivi che non siano il risarcimento. Cioè in mancanza di più ampie azioni tese a risocializzazione specificamente la vittima e tali da fornire la prova inequivocabile, da parte del diritto e delle istituzioni della società civile, di un incremento della responsabilità sociale anche nei confronti delle vittime. Una responsabilità fatta di specifiche misure di sostegno, che aiutino queste persone a sentirsi meno vittime – cioè a sentirsi meno vittime delle stesse procedure del diritto, oltre che del danno derivante dal reato subito. A ben vedere, resta aperta una domanda che può essere così formulata: la sola alternativa alla pena che cosa offre alle vittime, in alternativa a quell’aspettativa di punizioni esemplari che il diritto stesso ha ingenerato?
Del resto, dal punto di vista psicodinamico, una perfidia del male, nonostante la celebre banalità del male, risiede probabilmente nel fatto per cui il pentimento/ravvedimento di chi ha commesso il male richiede un’operazione mentale più facile da compiersi rispetto a quella che è chiamata a compiere chi il male lo ha subito e che consiste nel liberarsi dallo spettro della vendetta. Lo conferma il riscontro del fatto paradossale per cui proprio le vittime – a cui il paradigma riparativo dedica la massima attenzione, proponendosi di prenderne in carico i bisogni loro negati dal diritto – sono coloro che esprimono la più decisa resistenza – singolarmente o attraverso le associazioni che le rappresentano – a convergere sul tema dell’inutilità della pena. Tant’è che per l’appunto le vittime si annoverano tra i principali fautori dell’inasprimento delle sanzioni punitive.
Oblatività
Il tema più dibattuto e per molti versi più problematico riguarda la dimensione per così dire oblativa, che pure è centrale per la RJ. Da più parti, si ha in sostanza l’impressione di un’aspettativa di perdono, che indubbiamente ha un significato etico forte. C’è accordo sul fatto che il perdono non debba necessariamente rappresentare l’esito dei vari procedimenti o percorsi in cui si sostanzia il paradigma riparativo. Tuttavia, ciò che non converge sul recupero della relazionalità – da parte dei soggetti coinvolti nell’evento reato, nelle vesti di autore, vittima o membro della comunità – appare decisamente connotato in senso negativo dal punto di vista etico. Come dire che il paradigma riparativo, nel voler promuovere una reciproca assunzione di responsabilità, chiede ad entrambe le parti coinvolte nel conflitto di trasformare il ricordo del passato, ancorché ambiguo ed incerto, in volontà di superare il passato, pur senza dimenticare. Grazie alla memoria del passato, si può capire quali sono stati gli errori, nostri ed altrui, da non ripetere. Oppure, più semplicemente, si possono capire insieme alcuni perché, recuperando la relazionalità perduta. Il racconto del passato si trasforma così in storia di una realtà, piccola o grande che sia. Superare il passato non vuol dire perdonare dimenticando, seppure il perdono possa costituire un gesto di eroismo ricco di memoria. La memoria è diversa dal rancore come lo è dall’oblio. Posto ciò, resta tuttavia il problema della difficoltà – soprattutto per la vittima – di superare il passato, verso un futuro più ricco di sana memoria del passato.
In effetti, la posizione del condannato e quella della vittima hanno molto in comune ma sono anche diverse. Esse dispongono ad esempio di un minor grado di libertà. Vi è da un lato un maggior grado di libertà del reo, che dispone della “libertà” di aver commesso o non aver commesso un reato o – se si vuole – di aver arrecato o non aver arrecato un danno, nonché della libertà di pentirsi/ravvedersi o non pentirsi/ravvedersi (il pagare il proprio debito col diritto attraverso l’espiazione della pena non implica necessariamente né il pentimento, né il ravvedimento). Dall’altro lato vi è la “non libertà” della vittima, che può solo aver subito o perdonare, ancorché il perdono sia solo auspicabile o inteso come recupero della relazionalità.
Quest’aspetto appare oggi fortemente problematizzato, proprio perché in molti casi si è avuta la percezione che la vittima si senta costretta, dal sistema di RJ, ad esprimere la sola possibilità di reazione ritenuta “giusta” dal sistema.
È vero che entrambe le parti hanno un problema comune, che consiste nel trovarsi di fronte ad una rottura del patto sociale, cioè del legame – o della relazionalità – che consente la convivenza e tiene in piedi la comunità. Di quel legame è garante il diritto, nella misura in cui afferma un sistema di regole ed opportunità (il diritto che costruisce e rende possibile la convivenza) e nella misura in cui protegge il più debole dall’intemperanza del più forte (il diritto che tutela). Sebbene il problema del confronto con la rottura del patto sia comune a chi commette un reato ed a chi ne subisce le conseguenze, esso assume configurazioni psicologiche diverse per ciascuna delle parti in causa.
In termini psicodinamici, per il reo è paradossalmente meno accidentato l’accesso a forme di responsabilizzazione, attraverso l’elaborazione di una colpa che effettivamente egli ha commesso e che per l’appunto per questo motivo si può elaborare. Come dire: elaborare la realtà assumendola nel pensiero, fino a pensare al proprio aver agito in quel modo invece che in un altro, per quale ragione e sotto la spinta di quale impulso. In una battuta: pensare la colpa. La vittima si confronta invece col più complesso compito di trovare una risposta sostenibile ad una colpa oscura. Che è oscura proprio perché connessa ad un evento accaduto ma non agito [14]. In tal senso, la vittima è facilmente abitata da un fantasma persecutorio. Che non consiste nel bisogno di perseguitare e nemmeno consiste nel disagio che si prova nell’accorgersi di non potersi svestire dell’abito di figura persecutoria. Consiste soprattutto nel sentirsi minacciata da un fantasma interno, che non è una persona ma un interrogativo insoluto: è l’assurdo inspiegabile che, in quanto tale, diviene persecutorio. Si pone spesso l’accento sull’atteggiamento persecutorio verso altri, che è effettivamente evidente in molte persone che hanno subito le conseguenze di un reato. Ma più profondo ed assai più complesso da elaborare è invece il fantasma interno da cui la vittima si sente perseguita. La vittima si sente perseguitata da una parte di sé stessa: un persecutore “interno” (l’interrogativo insoluto) a cui – per definizione – è impossibile sottrarsi.
Pienamente comprensibile dunque la cautela degli operatori della mediazione penale [15], ben consapevoli del fatto che la mediazione si confronta col problema del male, o col problema dell’elaborazione del male. Di fronte a questo scenario ed in presenza di queste dinamiche, la mediazione è spesso chiamata a fare appello ad una sorta di “capacità negativa” [16], che vuol dire capacità di non saturare di contenuti il pensiero della “vittima”, in virtù di un assetto mentale di sospensione – da instaurare all’interno al dispositivo di mediazione – che la psicoanalisi definisce con l’evocativa espressione “senza memoria e senza desideri”. Dunque un assetto mentale senza aspettative preconfezionate – più o meno consapevoli – e senza condizionamenti teorici, che rischierebbero di distorcere il campo. In questa luce, da chiunque entra in mediazione – cioè anche da chi vi entra nelle vesti di autore di reato ma qui in particolare da chi vi entra nelle vesti di vittima – la mediazione non vuole semplicemente nulla. E per l’appunto in virtù di questo “non voler nulla” la mediazione può mantenersi viva, riuscendo a sostenere l’attacco – implicito o inconscio – che chi ha subito il male o chi lo ha commesso, conducono spesso al dispositivo. In particolare, il “non voler nulla” consente di evitare che l’intrusione di aspettative (gli schemi e le idee che la RJ sostiene) rischi di limitare la libertà della vittima – come peraltro ben sanno gli operatori della mediazione e come più o meno esplicitamente previsto dai protocolli più consolidati e più avanzati, che guidano oggi le procedure mediative.
D’altra parte, rispondere al male col bene non sempre è possibile e mai è cosa semplice. Si può aggiungere che, in una prospettiva psicologica e sociale, rispondere col bene può anche voler dire accettare l’odio degli altri o di un altro. Talvolta, il solo ascolto dell’odio – beninteso tenendo da parte ogni possibile forma, ancorché implicita, di riprovazione morale per l’odio o di collusione morale con l’odio – consente a colui che odia di oggettivare sia il proprio odio, sia l’odio in sé. Che è già un primo passo, di rilevanza cruciale.
Posto dunque che la mediazione penale costituisce lo strumento principe della RJ – quello che ne realizza l’obiettivo più ambizioso e che, dal punto di vista della teoria, certamente sviluppa appieno la potenza del paradigma riparativo e restitutivo – resta il fatto che, almeno al momento, la mediazione “è di tutti ma non per tutti”. Le “resistenze” che spesso vi oppongono le vittime – individualmente o attraverso i loro organismi di rappresentanza – ne pregiudicano l’applicazione su più ampia scala. La capacità della mediazione di offrire una risposta forte ai bisogni delle vittime è inoltre limitata da un’evidenza per così dire banale: la maggior parte dei reati – e del danno che ne deriva alle singole persone – non comporta l’individuazione di un responsabile. Come dire che il modello classico della victim offender mediation risulta effettivamente proponibile solo in riferimento ad un numero relativamente esiguo di reati. Evidenza che esorta peraltro a valorizzare le opportunità offerte dalla mediazione aspecifica e dalle forme di riparazione “reato aspecifiche”.
Si può perciò dire che la RJ viene oggi fortemente e da più parti sollecitata a problematizzare ulteriormente il tema dell’attenzione ai bisogni della vittima, anche al di là dell’offerta di mediazione penale. L’orientamento per molti versi prevalente è infatti quello di promuovere anche un incremento delle forme specifiche di sostegno alle vittime di reato ed in questa direzione si muove altresì l’Europa, come testimonia tra l’altro la recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE, che esplicitamente esorta in tal senso anche i servizi di giustizia riparativa.
La mediazione penale è lo strumento che giustamente riconduce l’elaborazione del male laddove la rottura del patto ha avuto luogo ed in ciò ne restituisce la gestione all’ambito della dialettica – o del dialogo – tra le parti coinvolte. Vi è tuttavia un’altra dimensione in cui le parole della RJ possono aprire spazi di elaborazione e reciproco riconoscimento delle persone, nella loro piena dignità. È la dimensione non già del rapporto – o della rottura della relazionalità – tra le parti coinvolte, bensì del rapporto che il diritto stabilisce ed intrattiene con ciascuna di esse. Dunque la dimensione in cui si colloca la responsabilità sociale sia nei confronti del reo che subisce la pena, sia – per altri versi – nei confronti della vittima che subisce le conseguenze di un reato.
Se si assume questo nuovo vertice di osservazione (guardando non alla dialettica tra le parti ma alla dialettica tra il diritto e ciascuna di esse) si può notare che, sebbene per ragioni diverse ed in modi diversi, entrambe le parti coinvolte nel conflitto che la rottura del patto comporta vengono a costituire capri espiatori delle logiche del diritto. Il reo, in maniera più evidente, nella misura in cui subisce la punizione della pena – ancorché meritata in ragione di un giusto processo. Ma nondimeno la vittima, nella misura in cui subisce quella seconda vittimizzazione, che si configura come tale in ragione del carattere afflittivo intrinseco alle procedure dell’amministrazione della giustizia che il diritto prevede. Basti pensare all’accidentato e doloroso percorso che bisogna affrontare dopo aver subito un reato. Un percorso fatto di denuncia, testimonianze, prove da dimostrare, onere di spese legali e quant’altro. Come dire che il diritto è sì spietato e per molti versi “atropemico”[17] nei confronti del reo ma lo è altrettanto nei confronti della vittima, seppure in modo meno palese e spettacolare.
Due capri espiatori del diritto
Il crimine non rende la vita serena e felice. Pensando alla qualità della vita, si parla spesso di “criminalità diffusa”. Ma la criminalità è criminalità, non si differenzia la grande criminalità dalla microcriminalità, nonostante esistano crimini più gravi e meno gravi, o meglio: che ognuno può sentire più gravi, di fronte ad altri che li sentono meno gravi. Non tutti percepiscono allo stesso modo la gravità di un crimine. Alcuni addirittura determinate azioni criminose non le considerano affatto tali. Si può parlare di mala prohibita, piuttosto che di mala in sé ma nessuno è ancora riuscito a risolvere il quesito che la criminalità solleva. Eppure sentiamo dentro di noi la criminalità, come una realtà che ci disturba, sebbene cerchiamo di difenderci dal crimine degli altri, certo molto di più di quanto siamo disposti ad ammettere i nostri. In questo senso, il crimine è qualcosa che ci circonda, che c’è sempre stato. La criminalità non solo è diffusa ma è anche universale. Ciò non vuol dire che si debba assumere un atteggiamento pacifico e rinunciatario, così come non siamo autorizzati ad accettare la malattia, né ora né mai, solo perché è sempre esistita. In accordo con quanto già ricordato nel primo paragrafo, non è velleitario andare contro il crimine, pur se la lotta contro il crimine è costantemente chiamata a fare i conti col fatto che non sappiamo bene cosa esso sia in realtà, dove cominci il crimine mio e dove quello dell’altro, dove inizi il crimine della mia società e dove quello della società dell’altro. Anche se sappiamo che combattere il crimine vuol dire tentarne una definizione, tentare cioè di dire ciò che è crimine e ciò che non lo è. Combattere il crimine significa dunque impegnarsi anche nell’impossibile impresa di dar senso ad un’esigenza profonda del crimine, che alberga in ogni essere umano e che va assolutamente al di là della storia individuale e talvolta persino di quella del gruppo: l’esigenza di delinquere appare radicata in tutti gli esseri umani, in noi e negli altri. Come alcuni segnalano a buon diritto, c’è da sorprendersi non già di fronte al fatto che, qualche volta, qualche persona commette un crimine, bensì di fronte al fatto che, molte volte, molte persone non commettono crimini! Sono così tante sia le cause interne all’individuo, sia quelle esterne, così come sono tanti i modelli esplicativi della criminalità – e ciascuno di essi corrisponde ad una particolare concezione dell’ordine sociale, nonché ad una determinata immagine del criminale, risultando perciò valido in sé ed utile per illuminare un particolare aspetto della questione criminale – che non sappiamo assolutamente porre rimedio in modo continuativo, senza scompensi.
In questa luce – e certamente lungi da qualsiasi giustificazione del crimine – si può dire che coloro che si rendono protagonisti del crimine vengono anche a costituire una sorta di valvola di sfogo delle tensioni che attraversano qualsiasi società. Valvola di sfogo necessaria e funzionale all’esistenza stessa di qualsivoglia consorzio sociale. Si parla infatti di criminalizzazione anche per definire quella funzione generativa della condotta criminale che viene svolta dall’assetto sociale, attraverso processi di costruzione ed attribuzione di maschere e ruoli. E non s’intende con ciò far riferimento alla forza delle “etichette” che contribuiscono ad inaugurare o rafforzare le carriere criminali o devianti, bensì al costante e continuo lavoro dell’inconscio sociale, nel dar forma e contenuto al divenire dell’esistenza di ciascuno e di tutti, attraverso dettami e prescrizioni – più o meno rigidi, più o meno stabili e certamente modificabili – che trascendono l’individuo e concorrono a costruire la trama di ruoli, riti, valori, bisogni e relazioni che definisce la struttura sociale di cui ogni individuo fa parte, alla stregua della tessera di un mosaico. Come dire che ogni società, anche attraverso il proprio ordinamento, contribuisce a costruire i propri criminali, così come le loro vittime. Solo per fare un esempio in proposito: dalle statistiche emerge tradizionalmente il riscontro pressoché universale di una bassa incidenza della criminalità femminile, a paragone con quella maschile. Pare che la criminalità, in quasi tutte le società conosciute, sia assegnata al maschio ed in ragione del suo ruolo sociale e culturale piuttosto che delle sue caratteristiche individuali – come sembrano confermare i trend in crescita della criminalità femminile laddove i ruoli connessi alle variabili sessuale e di genere divengono meno rigidamente definiti. In tal senso, la figura maschile è per molti versi socialmente e culturalmente “destinata” ad assumere su di sé l’onere della condotta criminale, dunque l’onere di una maggior criminalizzazione. Un altro esempio meno problematico ma altrettanto evidente: in riferimento alla devianza minorile, c’è ampio accordo intorno all’idea che dietro un ragazzo che ha sbagliato o che sta sbagliando ci sia sempre un mondo di adulti che non ha fatto abbastanza per evitare che ciò accada.
Posto ciò – e visto anche il riscontro che, com’è noto, l’efficienza del diritto sembra estrinsecarsi prevalentemente nei confronti dei soggetti più deboli – si può dire che il “reo” viene anche a costituire un capro espiatorio, nella misura in cui sconta – beninteso: a buon diritto, cioè in ragione di un giusto processo – le colpe di tutti. E si potrebbe in proposito trovare appoggio nell’enigma del Crucifige!, sentenza “senza causa” del processo a Gesù, di fronte a Pilato, Barabba ed alla “folla”, di cui raccontano i passi della tradizione evangelica. Tema che però porterebbe ora lontano dal focus di questa riflessione. Riflessione che vuole invece richiamare l’attenzione su un punto: la questione della responsabilità sociale nei confronti del reo è stata molto problematizzata, nell’ambito del diritto e nell’ambito della RJ, nel senso ampiamente ricordato nei paragrafi precedenti. E come già accennato in quei paragrafi, si ha l’impressione che la RJ sia oggi chiamata a problematizzare maggiormente anche il tema della responsabilità sociale nei confronti di un altro capro espiatorio: la vittima. Infatti, la vittima non è vittimizzata solo perché subisce le conseguenze di un reato. Essa diviene un capro espiatorio non solo della violenza del crimine, bensì diviene un capro espiatorio anche della violenza del diritto, nella misura in cui, in conseguenza del reato, viene sottoposta a quel tabù di esclusione e di isolamento [18] che le procedure del sistema di amministrazione della giustizia comportano.
Filottete
Problematizzare il tema della responsabilità sociale nei confronti delle vittime significa valorizzare e promuovere tutte le specifiche misure di ascolto, aiuto e sostegno alla vittima che sono “reato-aspecifiche” e che si configurano come forme di condivisione nel tessuto sociale di una parte dei disagi che l’esser vittima comporta (da quelli economici a quelli relativi al rapporto con gli attori del law enforcement e con la comunità tutta). Attenzione: misure di sostegno sociale e non esclusivamente misure giuridiche. Dunque misure che sottraggono l’amministrazione della giustizia al monopolio del diritto, per aprirla invece ad un sistema per così dire “a più attori”. Un sistema che certamente prevede il coinvolgimento, insieme agli attori del law enforcement, degli enti locali e di tutte le agenzie a vario titolo coinvolte nella promozione del cosiddetto welfare. Su questo terreno trovano ampio spazio le parole della RJ, attraverso gli strumenti e le tecniche, a base prevalentemente “comunitaria”, di cui essa dispone [19]. Ne costituiscono alcuni esempi: il Community/Family Group Conferencing; i Compensation programs; gli sportelli di ascolto, sostegno ed orientamento alle vittime di reato, di competenza degli enti locali, o i gruppi di condivisione ed elaborazione dell’esperienza di vittimizzazione, sganciati dalle procedure del diritto e del law enforcement ed ispirati al modello del Victim/Community Impact Panel, oppure ai principi del self-help. Si tratta, come si vede, di misure alla portata di qualsiasi rete di enti locali e pubbliche amministrazioni, sia dal punto di vista della relativa facilità di realizzazione, sia dal punto di vista dell’impegno di risorse economiche ed umane. Il loro pregio, vista anche la loro sostenibilità, risiede nell’aprire la via alla costruzione di un “ruolo” diverso per la figura della vittima, rendendola meno sola nella sua condizione di vittima colpita da un reato – reato che solo qualche volta ha un responsabile e nella maggior parte dei casi non lo ha – e meno sola nella sua condizione di vittima spesso umiliata, se non afflitta, dalle procedure del diritto. In una battuta: rendere le vittime meno vittime e più persone, restituendo loro dignità.
Ciò ha ancor più valore in contesti come quello italiano, in cui l’azione di sostegno alle vittime ha preso prevalentemente piede secondo lo schema dell’associazionismo promosso da vittime che condividono la medesima esperienza di vittimizzazione, in una logica fortemente rivendicativa, non solo in termini pecuniari ma in termini di richiesta di inasprimento delle sanzioni. Aspetto che – come già ricordato – non può sorprendere, perché quanto più il sistema del diritto risulta alienante per le vittime, tanto più sollecita il loro risentimento. Ed almeno in Italia, ma non solo, questo settore dell’associazionismo avanza severe critiche e non poca ostilità anche nei confronti del mondo della mediazione penale e di tutta la RJ, di cui dovrebbe invece costituire un alleato valido e prezioso, superando le strettoie del “lobbysmo” e della difesa dei particolarismi.
Responsabilità sociale nei confronti delle vittime, all’interno di un sistema di giustizia “a più attori”, significa dunque riconquistare la fiducia della figura della “vittima” e la sua rinnovata partecipazione alle dinamiche di coesione della comunità – lo stesso vale certamente anche per la figura del “reo”. La figura della “vittima” e parimenti quella del “reo” possono entrambe esser riconquistate ad una più “sana” relazionalità, nella misura in cui l’azione di sostegno sociale riesce ad aiutarle a liberarsi delle “maschere” che il diritto impone loro. Perché avere maggior serenità è possibile, se le maschere ed i ruoli che pure costituiscono la persona non ne diventano anche il carcere.
Torna di nuovo anche qui utile un riferimento al mito: quello di Filottete, come elaborato da Sofocle nella tragedia omonima. Composta dal drammaturgo ateniese sulla soglia dei novant’anni, il Filottete è la sua opera forse meno celebrata, ma non la meno studiata. Tra i molti quesiti che essa solleva, l’esegesi moderna ha posto l’accento sulla sua dimensione socio-politica, con riferimento alle istituzioni sociali, che sono anche giuridiche e politiche insieme. La tragedia – peraltro “a lieto fine”, ancorché in virtù di un intervento ex machina – racconta la storia di uno dei mitici re dell’impresa troiana, abbandonato dai compagni su un’isola deserta, perché durante il viaggio era stato morso da un serpente e la ferita, anziché rimarginarsi, perdeva sangue male odorante e gli procurava atroci dolori. Per l’appunto le sue grida ed i miasmi della ferita avevano motivato l’abbandono dell’eroe in un luogo solitario, col solo conforto dell’arco e delle frecce ricevute in dono da Eracle. Già da dieci anni Filottete soffriva e si torturava per l’ingiustizia subita, quando il responso dell’indovino indicò agli Atridi che la città non sarebbe stata espugnata senza il concorso di Filottete e del suo arco divino. Sarà il potere della persuasione – ad opera di Neottolemo ed in contrapposizione all’inganno suggerito da Odisseo – che riuscirà a vincere la diffidenza di Filottete. Con l’intercessione di Eracle ex machina, l’eroe abbandona l’isola e segue Neottolemo fino a Troia, dove conquista gloria immortale, dopo che gli Asclepiadi l’hanno guarito dal suo male. Questa, in estrema sintesi, la trama.
La ricchezza del mito espone sempre al rischio di banalità qualsiasi commento. Accettando questo rischio, lo si è voluto richiamare qui perché la ferita parla della morte civile, come l’isola deserta parla del tabù di esclusione ed isolamento, che si associa all’odio suscitato dall’ingiustizia subita e dal tradimento da parte dei compagni. La promessa di guarigione implica dunque una cura dell’anima e del corpo, con conseguente reintegrazione nella società. Ed in questa luce, il cuore della vicenda sta nel significato delle parole e degli argomenti di persuasione e philìa: i valori che consentono di riconquistare Filottete ad un impegno che non può giungere a compimento senza il suo contributo.
Argomentare col destino
La RJ incontra persone che portano le vesti – o la maschera – di “reo” o di “vittima”. Vesti o maschere che queste persone assumono nell’entrare in contatto col sistema del diritto, in conseguenza di un “evento reato” e del danno che ne deriva. Le parole e gli strumenti della RJ – dalla mediazione penale agli altri dispositivi riparativi – mirano a restituire ad entrambe le parti coinvolte nel reato la loro dignità di persone. Ciò vuol anche dire far sì che queste persone non restino prigioniere del ruolo – di reo o di vittima – imposto loro dal diritto, oltre che dal reato. Dunque far sì che quella veste o quella maschera non siano una gabbia. Il condannato che s’impegna in un percorso riparativo, invece di subire la pena, non è più soltanto “un reo”. La vittima aiutata nel sociale a sostenere ed elaborare la propria condizione di persona che ha subito un danno non è più soltanto “una vittima”.
La violenza del diritto è tale anche perché il diritto, nel nominare i ruoli di “reo” e “vittima”, sancisce un fato. Come la spada, che deve “de-cidere”, per render compiuto un procedimento, condotto soppesando equamente le ragioni, con occhi bendati nei confronti di qualsiasi privilegio. La RJ, in quanto aspirazione, sogno o nostalgia di una possibile giustizia, si pone il problema di non pronunciare una parola definitoria, che risulterebbe disperante se venisse a confermare l’ineludibilità di un ruolo e di un destino. Le parole e gli strumenti della RJ mirano infatti ad aprire spazi di agibilità, di libertà, di manovra. Possibilità invece di prigioni. Possibilità di recitare meglio la propria parte – e non una parte soltanto – sul palcoscenico della vita. Dunque possibilità di argomentare col destino, per non esserne schiacciati. E la possibilità di argomentare col destino risiede in quella modalità “erotica” di cui s’è detto ed a cui si riferisce anche il titolo di questo contributo.
Il problema di trovare argomenti da opporre all’ineludibilità del destino è per altri versi condiviso anche dalla psicoanalisi, che sin dalle sue origini ha voluto rappresentare quest’idea prendendo in prestito le figure incisivamente chiare della tragedia attica, in primis quella del re Edipo: colui che volle sapere [20]. Nella tragedia attica, il destino tutto coordina. È la forza oscura che sta alle spalle della Moira (letteralmente “la parte assegnata a ciascuno”). Non ha volto né nome perché può prendere il volto di chiunque, nascondendosi o manifestandosi non sempre allo stesso modo. Talvolta gli dèi impersonano l’estrinsecarsi del destino ma spesso ne sono anch’essi soggiogati. Gli dèi e gli uomini si scontrano con un’oscura ragione e le vicende umane oscillano tra i dettami del destino, il potere degli dèi e la volontà degli uomini. Gli dèi e gli uomini dettano leggi, il destino prevede e le sue leggi non dipendono da un potere o da una volontà ma dall’inesorabilità di ciò che deve inevitabilmente essere. Il destino non ha potere perché semplicemente è. I personaggi della tragedia attica tentano spesso di opporsi al destino, altre volte di allontanarlo o ignorarlo. La parola del destino, che improvvisamente si inserisce nella vita umana, talvolta non si mostra come dettame ma come semplice previsione. Previsione ineludibile, dunque giusta, perché quella era “la parte assegnata”, in accordo con una giustizia che non lascia alcuna possibilità e sancisce la più totale impotenza dell’individuo, di fronte alla verità del destino. La sola possibilità risiede nell’opporsi al destino, per l’appunto problematizzando il rapporto tra il vero ed il giusto. La possibilità che ciò che è vero non sia giusto. Il valore e l’attualità della tragedia attica risiedono nel non dare soluzioni a questo problema ma nell’esortare alla guarigione. Che è anche il progetto della psicoanalisi e della RJ. Almeno per la psicoanalisi, la guarigione si configura come “andare in cerca”, guidati da Eros.
La psicoanalisi non può essere ottimista, non può raccontare favole di sviluppo e progresso, nonostante il brain imaging, perché al di là delle affermazioni dei tanti Candide non viviamo nel migliore dei mondi possibili. Ma non per questo la psicoanalisi si arrende alle Cassandre del nichilismo e della rassegnazione. La psicoanalisi resta viva nella misura in cui riesce a dischiudere possibilità. Non soluzioni ma possibilità di desiderare un’esistenza piena, felice, appagante, sapendo che questo desiderio è destinato ad una parziale frustrazione e ad una continua riformulazione. E lavorando su fantasie, paure e desideri, la psicoanalisi vive di interpretazioni, pur se il suo dio è Eros e non già Ermes. Interpretare significa infatti costruire una storia, cioè ritrovarla insieme a chi ne è stato protagonista. L’interpretazione affonda nella persona, che si sente mutare. E la verità è una scommessa che ha senso giocare insieme agli altri o ad un altro. Scommessa che si perde, anche, sempre, un poco.
Il paradigma riparativo, soprattutto quando opera in complementarietà col sistema penale, lavora in un campo certamente diverso da quello della psicoanalisi, anche perché è chiamato a confrontarsi con la realtà dei fatti, oltre ad occuparsi dell’elaborazione dell’esperienza di quei fatti. Ad ogni buon conto, la RJ lavora anch’essa con le persone, per cercare insieme la strada lungo la quale colui che è vittima e colui che è colpevole – del resto, nel corso di un “processo” psicoanalitico, tutti ci scopriamo anche in queste vesti – possano trovare “spazio di manovra” per sottrarsi a quel destino, cioè alle conseguenze di un evento che peraltro è stato ed in sé non è modificabile. In ciò la RJ si cimenta con la questione della memoria e del ricordo, conducendo un’operazione che rende attuale il passato, per curare il presente. È la storia di ieri che si riattualizza, con tutta l’ambiguità del passato e del presente, facendo in modo che, oggi, ciò che è stato non rimanga un immoto presente.Il lavoro sul passato e sul futuro si rivela utile per modificare il presente e riformulare le ipotesi del futuro. L’accertamento di una verità inevitabile apre così la possibilità di ricostruire un progetto esistenziale dall’inizio al termine. Come dire che, sebbene possa sembrare assurdo e paradossale, ricostruire e curare il passato sono possibilità del presente. La RJ si preoccupa del benessere degli esseri umani e lascia in secondo piano l’esigenza di verità, poiché la verità mal pronunciata e peggio ascoltata non libera ma costringe. In questo senso, la RJ riconosce un’intrinseca impossibilità alla giustizia, quale affermazione di un principio di responsabilità e causalità. Ogni evento umano, come già ricordato, solleva la domanda del perché e perché a me. La risposta non sta nei codici, ma si dà la possibilità di cercarla – o ritrovarla – nell’incontro tra persone ed è in ciò che la RJ lancia una sfida al concetto di giustizia, così come comunemente inteso. La risposta non sta neppure nella memoria di quel che è stato, per come lo raccontano coloro che intendono la memoria come principio di verità. La memoria cui attinge Eros è la memoria dell’aedo e del mitografo, memoria che si rinnova e si moltiplica: che prospetta le mille facce dell’umana realtà.
NOTE
[1] Definizione proposta per la prima volta nel 1984 dallo psicoanalista francese Jean Bergeret (La violence fondamentale, Dunod, Paris 1984) e successivamente ripresa da quest’autore in riferimento ad un livello elementare di difesa, che «costituisce un istinto di vita, o piuttosto di sopravvivenza, cioè un atteggiamento mentale puramente difensivo nei confronti dell’altro, senza nessuna connotazione di odio o sadica, ma anche senza che una colorazione nettamente libidica possa già organizzare la relazione … puro istinto di conservazione, non è in sé stessa né “buona” né “cattiva”. Semplicemente esiste in quanto dinamismo primario» (La violenza e la vita, 1994, Borla, Roma 1998, p.69). La violenza fondamentale non va confusa con l’aggressività, perché costituisce una difesa compresente al gesto vitale, finalizzata a preservare l’integrità del soggetto. L’aggressività invece non può essere intesa come istinto primario, bensì come reazione secondaria alla frustrazione del desiderio per l’altro (dice freudianamente Bergeret: frustrazione proveniente dall’oggetto) rappresentata in ambito clinico dalle difese secondarie, sadomasochistiche o narcisistiche (quelle che insorgono di fronte alla frustrazione, cioè di fronte allo scacco della relazione).
[2] Efficace espressione pronunciata da Claudia Mazzucato nel suo contributo al film “Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa”.
[3] Il termine “problematizzare” si deve a Michel Foucault, che lo utilizza per alludere ad un’operazione di ri-orientamento di un punto di vista consolidato su un qualsiasi campo dell’esperienza umana. Quest’operazione non implica una rinuncia della possibilità di chiarire e spiegare, né pregiudica questa possibilità, bensì serve ad ampliarne le prospettive.
[4] L’avverbio “classicamente” indica quel tratto originario della psicoanalisi, di stampo vagamente illuminista, che esorta a conoscere acquisendo consapevolezza di ciò che non è consapevole, ovvero di ciò che è fuori del campo di coscienza ed in quanto tale costituisce una delle dimensioni cardinali dell’inconscio. L’avverbio “classicamente” implica nondimeno un riferimento all’altrettanto originaria accezione della psicoanalisi come procedimento che, attraverso la presa di coscienza, intende “integrare” le funzioni della mente ed i vari aspetti dell’attività psichica (ovvero del funzionamento mentale). Secondo il motto: rendere pensabili i pensieri non ancora pensati, evitando frettolose rimozioni o pericolose scissioni. Ovvero: aprire ponti e varchi per integrare le varie componenti dell’apparato psichico, evitando che una rigida segmentazione del funzionamento mentale si traduca in costruzione o consolidamento di muri.
[5] In epoca contemporanea, ne sono alcuni – tra i molti altri – punti di riferimento: il saggio Per la critica della violenza di Walter Benjamin (in Angelus novus, Einaudi, Torino 1962) gran parte della ricerca sulla questione del potere, condotta da Michel Foucault e la teoria di René Girard sulla violenza rituale e l’ambivalenza del sacro. Il tema “diritto e violenza”, in tempi più recenti, è stato anche ripreso da angolature diverse, ad esempio con riferimento all’analisi del potere costituito e del paradosso della sovranità (come nel caso dell’opera di Giorgio Agamben) o con riferimento al dibattito sulla communitas, cioè sull’origine e sul destino della comunità, intesa come ciò che abbiamo in comune, ciò che ci unisce agli altri (è il caso dei lavori di Roberto Esposito).
[6] La “fusione” o “indifferenziazione” di diritto e violenza nella sovranità della legge è – non senza ironia – accennata nel frammento 169, in cui il poeta/teologo, con riferimento al mito di Eracle, parla del nòmos basileus: «il nòmos sovrano dei mortali e degli immortali conduce con mano più forte giustificando il più violento». Il tratto ironico è intrinseco all’allusione al fatto che Nòmos è il principio sovrano, che opera “con mano più forte”, nel senso di più violenta, l’unione di due opposti per eccellenza, quali sono Bìa (la violenza) e Dike (la giustizia).
[7] All’interno del dibattito sulla violenza della legge, sui rapporti tra individuo e società, sull’origine della comunità, su ciò che quest’ultima tiene insieme – determinandone dunque il futuro – conservano a tutt’oggi il loro valore i classici contributi di Sigmund Freud, in particolare il tema della colpa fondativa dell’ordine sociale (di cui in Totem e tabù, 1913) e quello della rinuncia pulsionale (di cui ne Il disagio della civiltà, 1929).
[8] Tra gli altri, Umberto Curi in Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica, Christian Marinotti Editore Milano 2003.
[9] La suggestione agisce come fascinazione, creatrice delle verità a cui l’essere umano può accedere. Ricordando il sofista Gorgia da Leontini, il discorso che si fa musica, ritmo e poesia diviene quel pharmakon che, con tutta l’ambiguità contenuta nel termine, può essere veleno o salvezza. Secondo questo geniale teorizzatore della suggestione, tre sono gli elementi che la spiegano: un influsso esterno (il logos o discorso persuasivo) una disposizione interiore ad essere suggestionati (la doxa o opinione) ed il giusto momento in cui il processo si verifica (il kairos o tempo opportuno). La relazione tra suggestione ed innamoramento ha peraltro origini molto antiche: nella Teogonia di Esiodo, Peitho, figlia di Oceano e Teti, è la divinità della persuasione o suggestione, con particolare riferimento alla suggestione d’amore. Il pensiero psicoanalitico, già con Sigmund Freud, ritiene che questo fenomeno rimandi ad un particolare aspetto della relazione amorosa, in cui un soggetto s’innamora in maniera identificativa, ovvero si rivolge al suggestionatore con «una dedizione amorosa illimitata che esclude il soddisfacimento sessuale» (Psicologia delle masse ed analisi dell’Io, 1921, in Opere, vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 1978, p.279) attribuendo all’altro peculiari funzioni della propria psiche, quali l’esame di realtà e le funzioni dell’ideale dell’Io. Maggior attenzione vi dedica Sandro Gindro che, in linea col progressivo distacco della psicoanalisi dall’idea del narcisismo primario (distacco ben descritto, tra gli altri, da Morris Eagle in La psicoanalisi contemporanea, Laterza, Bari 1988) considera la psiche in relazione col mondo sin da subito e vede perciò nella suggestione una delle modalità primarie di strutturazione della vita psichica: «Tutti viviamo nella situazione della cosiddetta suggestione post-ipnotica: qualcuno, da qualche parte, ci ha suggestionati, e noi razionalizziamo le nostre suggestioni. Ecco perché il mio inconscio non è mai il mio, ma, come ripeto, è sempre a metà tra me e gli altri; perché io vivo di suggestioni e senza le suggestioni, come senza le proiezioni, saremmo tutti rigorosamente e squallidamente identici … dove finisce la suggestione e comincia la realtà? Ecco ciò che io non voglio: che si distingua suggestione da realtà, perché la suggestione è realtà: è un modo di costruire la realtà. Certo poi bisogna analizzare i tipi di suggestionabilità o di realtà, ma la suggestione non è fantasia, la suggestione è il nostro modo di vivere la realtà. Al di là della suggestione non possiamo andare, e questo vale per le domande che si possono fare, per le risposte e per le convinzioni: noi viviamo nella suggestione e ci costruiamo nella e attraverso la suggestione» (La paura dell’inconscio, dispense dei seminari 1979-80, Psicoanalisi Contro, Roma, policopiato, p.71).
[10] Dopo aver delineato la prospettiva teorica in cui si collocano alcuni spunti di riflessione che questo contributo intende proporre sul tema della RJ – e sui quali si ritornerà nella parte conclusiva – vengono di seguito presentate altre considerazioni che derivano invece, oltre che dalla visione del film “Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa”, dalle osservazioni sul campo condotte con gli strumenti ed i metodi della ricerca sociale. Queste osservazioni fanno comunque riferimento al medesimo apice teorico, nel senso che ad esso si ispirano e, nel contempo, lo alimentano. Esse discendono principalmente dall’esperienza dell’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali in tema di formazione e valutazione di programmi di mediazione penale minorile e giustizia riparativa. Un’esperienza maturata sin dal 2004, a partire dal Progetto “In-contro” (promosso dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” 2000-2006) che perseguiva i seguenti obiettivi: diffondere la cultura della mediazione, con particolare riferimento alla mediazione penale in ambito minorile; promuovere la formazione di mediatori e la costituzione di gruppi di mediatori capaci di lavorare in un’ottica di rete; favorire e sostenere la realizzazione di un sistema integrato tra enti pubblici e privati in materia di mediazione. Negli anni successivi, l’esperienza dell’Istituto in questo campo si è poi consolidata attraverso la realizzazione di numerose altre iniziative di studio e ricerca. Più in particolare, le considerazioni proposte in questo contributo discendono da quanto rilevato nel corso dello svolgimento del recente Progetto “YO.VI – Integrated Restorative Justice Models For Victims and Youth”, promosso dal Dipartimento per la Giustizia Minorile, con finanziamento della Commissione Europea-DG Affari Interni e realizzato a partire dal 2013, in partnership con enti appartenenti ad otto paesi membri.
[11] Esemplare in proposito il ben noto effetto paradosso della detenzione, che molto spesso consolida o “professionalizza” lo sviluppo di carriere criminali, invece di scoraggiarne il perpetuarsi.
[12] La sicurezza è tradizionalmente intesa come condizione pacifica della convivenza, tale da consentire il pieno e libero svolgimento della vita collettiva, senza turbative derivanti da fatti di violenza, da ingiustificati allarmi, da disordini, nonché dall’azione di soggetti che, in forma singola o associata, perseguano il fine di commettere reati. Negli ultimi tre decenni tale nozione è tuttavia divenuta assai più complessa, anche in seguito al dibattito che ha posto l’accento sulla discrepanza tra l’entità dei fenomeni criminali registrati dalle Forze dell’ordine (la sicurezza cosiddetta reale) ed il livello di insicurezza percepito dalla popolazione (la sicurezza cosiddetta percepita). In particolare, ha assunto crescente rilevanza la connessione tra l’esperienza di sicurezza dei singoli individui e le condizioni di vivibilità del contesto locale di appartenenza, da cui è derivata la consapevolezza del fatto che la responsabilità della sicurezza non può essere solo delegata alle agenzie di controllo sociale ma dev’essere collocata – ovvero restituita – all’interno del contesto in cui la sicurezza stessa si determina. In questa luce, essa non è più una condizione “già data” – che sussiste o non sussiste in ragione della maggiore o minore efficienza delle misure di controllo sociale – bensì una dimensione da costruire: la sicurezza discende da quel processo di costruzione di rapporti di fiducia, che è in grado di generare un tessuto sociale cooperativo, la cui trama è costituita anche dalla disponibilità a condividere attivamente il sistema di vincoli ed opportunità, cioè di norme, che la comunità stessa ha assunto come proprio. Si tratta, in estrema sintesi, dell’esito di un “lavoro di coppia” tra l’azione istituzionale di promozione della legalità e l’azione sociale che conduce al rafforzamento del senso di appartenenza e della coesione interna alla comunità. La dimensione della sicurezza è così determinata dal convergere dei processi di acquisizione di capitale sociale – di cui è protagonista la comunità civile – e degli interventi di cui sono protagoniste le istituzioni, segno della presenza dello Stato nel fornire garanzie in termini di diritto e difesa della legalità, nonché nel promuovere la sicurezza in termini di salvaguardia e corretta applicazione delle leggi (componente a sua volta indispensabile per sostenere il ruolo delle amministrazioni locali ed il corretto sviluppo di capitale sociale nelle realtà territoriali). Tale crocevia è ben individuato dall’incontro delle due componenti della sicurezza a cui si riferiscono i termini security e safety, derivati dalla letteratura anglosassone. Il primo indica gli aspetti relativi alla presenza delle istituzioni ed all’efficienza delle misure di controllo sociale (law enforcement); il secondo riassume l’ampio insieme delle condizioni che configurano la possibilità di abitare un luogo non ostile e sufficientemente accogliente. Di fronte alla crescente richiesta di sicurezza e protezione nelle società occidentali, gli sviluppi del dibattito sociologico su questi temi hanno messo in luce che le ragioni dell’insicurezza sono complesse e non sempre pertinenti alle cause a cui l’insicurezza viene attribuita. Molti autori individuano infatti, nel corso degli ultimi decenni, una crisi della “modernità organizzata”, che comporta una sorta di ritorno dell’insicurezza sociale e l’insediarsi di quella che Ulrick Beck ha suggestivamente definito “la società del rischio” (La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000). Più recentemente Robert Castel (L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti, Einaudi, Torino 2004) in base alla disamina dei sistemi di protezione civile (libertà fondamentali, sicurezza delle persone e dei beni) e di quelli di protezione sociale (nei confronti dei principali rischi di degrado delle condizioni individuali, connessi ad esempio alla salute, agli infortuni, alla povertà nella vecchiaia) ha messo in guardia dall’avanzare della “mitologia della sicurezza”. Sebbene questi sistemi siano molto sviluppati – a paragone con altre epoche storiche – nelle attuali società occidentali il bisogno di protezione resta connesso anche alla percezione della minaccia. La mutata sensibilità verso i rischi aumenta il divario tra l’aspettativa di protezione (oggi molto elevata) e l’effettiva capacità di soddisfarla da parte della società. In sintesi: l’indebolimento delle capacità di risposta dei tradizionali sistemi di protezione sociale, unitamente alla comparsa di nuovi rischi per l’intera umanità (ad esempio i rischi naturali, quelli industriali, ecologici o sanitari) producono in seno alla società una sorta di “frustrazione securitaria”, che a sua volta distorce e dilata a dismisura la domanda di sicurezza, sollevando un interrogativo in merito a cosa effettivamente significhi “essere protetti” nelle società del rischio. Ampie frange di popolazione sviluppano così la convinzione di rimanere ai margini dei percorsi di evoluzione sociale, incapaci di controllare il proprio futuro. La frustrazione securitaria “sposta” la conflittualità sociale e dà luogo al riemergere di classi pericolose, su cui si cristallizzano le minacce veicolate dalla società. Sull’onda delle paure e dell’intolleranza, la questione sicurezza “slitta” dal piano sociale a quello del diritto e dell’ordine pubblico, operando un’impossibile scissione tra sicurezza civile e sicurezza sociale.
[13] Visto che si parla qui di “cura”, ancorché per allegoria e con riferimento al tema dei rapporti tra diritto e violenza, non è improprio citare in proposito – a puro titolo di esempio – l’influsso esercitato dalla dimensione risarcitoria sul progressivo affermarsi della cosiddetta “medicina difensiva”. Influsso che comporta l’innesco di vere e proprie dinamiche perverse nel rapporto tra medico e paziente, cui consegue la compromissione di quell’alleanza terapeutica, che pure costituisce uno dei presupposti dell’idea stessa di cura.
[14] In accordo con quanto fatto presente da Gherardo Colombo nel suo contributo al film “Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa”, la vittima di un reato è posta di fronte ad una duplice domanda: perché e perché proprio a me? La questione è affrontata da Colombo anche nel suo volume Il perdono responsabile, Ponte alle Grazie, Milano 2011.
[15] Un richiamo alla cautela ed alla sapienza del mediatore è esplicitato da Adolfo Ceretti nel corso del film “Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa”. In particolare, con riguardo al coinvolgimento della vittima, Ceretti – citando una frase di Claudia Mazzuccato – dice che: «La giustizia riparativa è per tutti ma non è da tutti».
[16] Termine proposto nel 1970 dallo psicoanalista Wilfred Ruprecht Bion, che lo mutua da un verso del poeta inglese John Keats.
[17] Termine suggestivo, originariamente introdotto da Levi-Strauss, ripreso da Jock Young in ambito criminologico e come tale utilizzato, in Italia, da Massimo Pavarini, per indicare le pratiche di rifiuto di ciò che è socialmente avvertito come pericoloso e che risultano tossiche nella misura in cui pregiudicano l’inclusione sociale e compromettono l’accettabilità dei livelli di convivenza civile. Come dire: un vomitare che avvelena.
[18] L’espressione “tabù di isolamento ed esclusione” allude non già alla posizione marginale della vittima all’interno del procedimento penale – aspetto per molti versi costitutivo del diritto – ma alla “diffidenza” che le procedure del diritto e la società tutta nutrono nei confronti di chi è stato “ferito”. Come dire un “ritorno”, diffuso nel tessuto delle relazioni sociali, del timore di quella devastante sete di vendetta, a cui per l’appunto si oppone l’istituzione del diritto sottrattivo. La vittima non ha certamente facoltà di vendicarsi ma, al di là delle forme più o meno superficiali di solidarietà sociale che può incontrare, resta persona per molti versi “sospetta”. Da compatire, perché potrebbe capitare a chiunque di trovarsi in condizioni simili, ma da guardare a distanza. È facile dire alla vittima “dimentica e guarda avanti”, soprattutto quando lo si dice per sottrarsi al peso della lamentela e dell’inutile – ancorché pervicace – rivendicazione di cui la vittima è portatrice. Anche per questa ragione, da parte di chi è vittima di un reato, è ovvio provare vergogna per la propria condizione di persona ferita. Le procedure previste dal diritto (dalla denuncia all’onere delle spese legali, nel senso già ricordato nel testo) troppo spesso non aiutano a fronteggiare quest’isolamento.
[19] Ne fornisce una completa ed approfondita disamina, avvalendosi del contributo del lavoro svolto dall’ISPAC-International Scientific and Professional Advisory Council, il volume di Grazia Mannozzi, La Giustizia senza spada. Uno studio comparato su Giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffré Editore, Milano 2003.
[20] Il re Edipo convocò il cieco indovino Tiresia: “… tra gli umani il solo che porti in sé, nativamente, il vero”, secondo le parole del coro, nell’Edipo re di Sofocle (verso 415). Dice Tiresia ad Edipo “cosa tremenda possedere il vero, ove a chi lo possieda altro non sia che inutile strumento” (verso 445). Tiresia è colui che sa e teme l’inutilità del proprio sapere, ove esso sia solo previsione di ciò che deve accadere e che accadrà comunque, nonostante le azioni che si potrebbero mettere in atto per impedirlo. La verità di Tiresia, che è la verità della psicoanalisi e di qualsiasi altra scienza, ha caratteristiche solo funeste ed è dunque inutile se l’uomo che la scopre o la conquista non può dirsi guarito, perché si ritrova schiacciato da essa, vittima impotente nelle mani del destino. È questo l’argomento centrale del già richiamato saggio di Sandro Gindro, A Tiresia, Psicoanalisi Contro, Roma 1983.