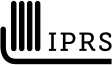Minori devianti e misure in area penale esterna
Siamo certamente ben consapevoli del fatto che i provvedimenti giudiziari eseguiti nei confronti di minori autori di reato non sono “pene”, bensì interventi di natura socioeducativa, tesi a tutelare il ragazzo ed a promuoverne il benessere, in base al principio per cui tale benessere include il comprendere e far proprio – da parte del minore – il valore della legalità, anche attraverso la revisione di eventuali condotte devianti o criminose. La scelta di parlare di significato della pena in questo articolo è infatti motivata dall’intento di proporre una riflessione preliminare sulle attuali modalità di amministrazione della giustizia e sulle agenzie a cui concretamente compete l’esecuzione degli interventi socioeducativi appena sopra accennati. In estrema sintesi, la riflessione è questa: le differenze tra giustizia minorile e giustizia – per così dire – ordinaria riguardano esclusivamente le specificità che contraddistinguono il minore rispetto all’adulto. Per il resto, il significato della pena è lo stesso: sia per i minori, sia per gli adulti. Nei confronti sia dei minorenni sia dei maggiorenni, la pena ha sempre un significato in primo luogo rieducativo[1]. Ed in ogni caso, a prescindere dall’età anagrafica e dal concetto di soggetto in rapida evoluzione e meritevole di particolare tutela – concetto prezioso, in accordo con le Regole di Pechino, con la Convenzione di New York e quant’altro – la giustizia è tale quando – e nella misura in cui – tende al recupero del condannato.
Pena e Community based sanctions
La cultura cosiddetta occidentale, non solo giuridica, ha prodotto romanzi come I Miserabili di Victor Hugo[2] e trattati come Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. E del pensiero di questi Autori – solo per citarne due tra molti altri – si è anche alimentata, giungendo a far sempre più propria, nel corso del tempo, l’idea che uno stato può dirsi etico nella misura in cui persegue costantemente la finalità di ravvedimento e recupero di chi ha commesso un reato, senza mai indulgere alle tentazioni della vendetta e sempre ripudiando il principio retributivo basato sulla comminazione di punizioni meramente afflittive. Già nel “teorema generale” delineato nel Settecento da Beccaria per determinare l’utilità di una pena si legge che: «perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi» (Dei delitti e delle pene, 1764, Capitolo XLVII, Conclusione). È da tempo sapere comune che la stessa dimensione afflittiva, ancorché ineliminabile, non dovrebbe mai esaurire il significato della pena, perché quest’ultima rappresenta sempre un mezzo, non già un fine. Nel pieno rispetto della celebre regola aurea kantiana, sebbene letta allo specchio: considerare l’uomo (in te stesso e nell’altro) come fine e mai come mezzo. E si vuole qui ribadire che ciò vale sia per i minori, sia per gli adulti.
Certamente, è anche noto che l’aspetto “vendicativo” della pena pare da sempre inscindibilmente connesso ad un’istanza sociale assai forte e spesso ricorrente, soprattutto di fronte a reati che suscitano grande riprovazione sociale[3]. Nonostante la ricchezza e la complessità delle questioni sollevate – tra gli altri – da Hugo e da Beccaria, ancorché pienamente acquisite dalla cultura giuridica, settori sempre più vasti dell’opinione pubblica restano invece saldamente ancorati ad una concezione arcaica e violenta del diritto[4], cioè ad un’irriducibile idea retributiva ed afflittiva della pena, che si traduce nella crescente richiesta di pene ispirate al principio dell’espiazione attraverso il dolore, tale da spingere un autore come Gustavo Zagrebelsky a parlare in proposito di “retaggio della premodernità” (la Repubblica di venerdì 23 gennaio 2015). Tuttavia, cedere a tale istanza è non solo in contrasto con l’altra istanza di eticità dell’intervento dello Stato, già ricordata menzionandone come latori Hugo e Beccaria, ma altresì pericoloso, come evidenzia, tra gli altri, Zagrebelsky.
Posto dunque che il discorso sul senso della pena è qui strumentale alla riflessione sulle attuali modalità di amministrazione della giustizia e sulle agenzie a cui concretamente compete l’esecuzione degli interventi socioeducativi, vale a questo punto ricordare un aspetto che ha contraddistinto la storia delle trasformazioni cui è andato incontro – in Italia e non solo – il luogo della pena per antonomasia: il carcere. E nel far ciò s’intende richiamare qui l’attenzione sia sul significato della tendenza a limitare il ricorso alla misura detentiva, sia sul significato dell’orientamento verso le misure tese a trasformare la misura intramuraria in qualcosa di più utile[5], sia in termini di sostenibilità da parte di chi la espia (cioè nel rispetto dei diritti umani fondamentali, peraltro garantiti dalla Carta costituzionale) sia in termini di vantaggio sociale (recupero alla socialità del soggetto deviante, riparazione della vittima, diminuzione della recidiva, incremento della percezione di sicurezza reale e quant’altro). In sintesi: l’evoluzione del sistema sanzionatorio (le modalità di amministrazione della giustizia) e del sistema carcerario (l’operato strategico delle agenzie a cui concretamente compete l’esecuzione degli interventi socioeducativi) è stata influenzata dal progressivo affermarsi delle cosiddette community based sanctions[6]. Come dire che, se si guarda il tutto da questa prospettiva, si può notare una crescente predilezione per tutto ciò che configura una valida alternativa alla “tradizionale” misura detentiva. E vale soffermarsi per un momento su questo punto, per chiedersi il perché.
Vi sono ragioni che nulla hanno a che fare con la riflessione sul senso della pena e riguardano invece i costi delle strutture detentive ed il loro sovraffollamento. Ragioni in parte analoghe alle precedenti rimandano ai costi sociali, legati agli impatti che la detenzione può avere sui nuclei familiari. Impatti di natura sia affettiva, sia economica, che – anche qui – comportano costi sociali aggiuntivi in termini di welfare. Altre ragioni sono invece direttamente riconducibili alla riflessione sul significato della pena: il riscontro di una maggiore efficacia degli interventi extra murari ed una sorta di crescente diffidenza – di cui si dirà tra breve – nei confronti della struttura carceraria. Altre ragioni ancora si individuano nella possibilità di impiego del condannato in lavori socialmente utili, che in ampia misura rappresentano un’azione restituiva nei confronti della società.
Indubbiamente, sono dunque molte e di vario ordine le ragioni che hanno spinto verso un crescente ricorso a forme di community based sanctions. Ma a prescindere dalla molteplicità di ragioni che ha concorso a determinare questa progressiva trasformazione, l’esito della trasformazione è univoco: sempre più spesso il condannato non resta separato dalla società. Come dire che l’esecuzione della misura penale non comporta più l’affidamento del condannato, da parte della società, ad una sorta di microcosmo parallelo, specializzato nella sua gestione e nel suo trattamento. Va in sostanza perdendo via via appeal l’idea che l’organizzazione sociale debba prevedere l’esistenza di luoghi separati, sorta di mondi paralleli, deputati alla segregazione dei soggetti “strani”, devianti, freaks[7] o folli. Ecco la diffidenza nei confronti del carcere.
Ricordando ancora l’opera di Michel Foucault – ed in particolare per gli aspetti già menzionati prima in nota – il tema della follia è certamente un emblema dei processi di costruzione sociale e gestione separata della diversità. E, sulla stessa linea, l’affermarsi delle community based sanctions va guardato tenendo anche conto dello spirito della “anti psichiatria” degli anni Settanta del Novecento, a cui si deve l’acquisizione che l’ospedale psichiatrico produce follia, oltre a tentare di porvi rimedio. Detto in altre parole: la cura è malata e bisogna in primo luogo curare la cura, con l’obiettivo di renderla più sana. E la cura più sana – o meno malata, se si preferisce – per porre rimedio alla follia è quella che si fonda sul principio in base al quale il disagio mentale dev’essere affrontato, trattato e gestito all’interno della comunità al cui interno esso insorge o si manifesta. I folli che la comunità produce debbono essere curati dalla comunità a cui appartengono – nonostante la loro condizione. Allo stesso modo, seppur mutatis mutandis, l’esecuzione penale che la giustizia prescrive dev’essere realizzata non già in un altro luogo – ovvero “rimossa”, nel senso di ricacciata e segregata in un luogo “altro”, con esplicito riferimento ad una delle accezioni della nozione psicoanalitica di inconscio – ma all’interno del contesto sociale. Dunque l’esecuzione penale dev’essere realizzata all’interno della comunità di appartenenza e ad opera degli attori sociali che ne fanno parte. Ecco il ruolo del volontariato e del privato sociale, del mondo del lavoro e della formazione e quant’altro. Cioè il ruolo dell’insieme di agenzie ed attori, che certamente non partecipa a pieno titolo all’amministrazione della giustizia – nella misura in cui l’amministrazione della giustizia resta prevalentemente monopolio del diritto – ma senza dubbio è protagonista nel costruire le modalità di esecuzione dei provvedimenti. Perché individua e mette in atto gli interventi socioeducativi, di recupero e di riparazione, che realizzano quel che si chiama giustizia di comunità.
Se a questo punto si considera il momento dell’esecuzione delle misure alla stregua di un aspetto fondamentale dell’amministrazione della giustizia (dunque fondendo in uno i due aspetti che all’inizio di quest’introduzione si era voluto tenere distinti) è lecito dedurre che, in maniera crescente, la comunità avverte l’esigenza di non poter più delegare la gestione delle procedure penali. La comunità è divenuta consapevole del proprio diritto ad esprimere il consenso ed a farsi partecipe delle decisioni in merito a tutto ciò che la riguarda. In una battuta: la comunità tende irreversibilmente a sentirsi responsabile e ad esercitare attivamente tale responsabilità. Dunque non accetta che la gestione della giustizia sia affidata ad un mondo parallelo, in cui vigono regole e consuetudini radicalmente diverse da quelle che informano e caratterizzano la vita della società civile. Non c’è più spazio per costruire luoghi – o “non luoghi”, con esplicito riferimento al significato che Marc Augé[8] ha attribuito a quest’espressione, seppur riferendosi a dimensioni diverse da quelle qui prese in considerazione – in cui non sia rispettata la dignità della persona, nella sua accezione più alta e piena. E se questi luoghi/non luoghi ancora esistono, è opportuno smantellarli.
Questi luoghi/non luoghi in effetti esistono ancora, seppur sempre di meno – fatto salvo forse l’esempio delle strutture di così detta “accoglienza” per migranti, la cui discussione, peraltro assai complessa, porterebbe ora lontano dal focus di questo scritto. Rimanendo ancora sull’asse delle analogie tra evoluzione di alcuni aspetti del sistema psichiatrico ed evoluzione di alcuni aspetti del sistema di giustizia penale, vale in proposito ricordare lo psicoanalista romano Sandro Gindro che, con lo spirito manifestamente polemico che per molti tratti lo contraddistingueva – peraltro evidente dalla sigla “Psicoanalisi Contro”, a cui aveva voluto legare il suo nome negli anni Ottanta del Novecento – in merito al significato della Riforma Basaglia, scriveva nel 1984 un articolo intitolato “Bisogna distruggere gli ospedali”, per far presente che il manicomio è solo uno dei luoghi/non luoghi in cui la dignità umana viene sistematicamente negata ed in cui si mostra perciò, in tutta la sua evidenza, la necessità di “curare la cura”. Dunque non l’unico luogo meritevole di abolizione, tra quelli su cui si fonda il Sistema di salute pubblica.
[1] In accordo peraltro col dettato della Costituzione italiana, in cui si legge, all’art. 27 che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
[2] In merito ai rapporti tra l’opera di Hugo e la cultura giuridica, volentieri si rimanda al pregevole contributo di Francesco Palazzo: Victor Hugo, I miserabili, la giustizia penale, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno “Giustizia e letteratura” (12 marzo 2015), organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno.
[3] Sui rapporti tra vendetta e radicamento del paradigma afflittivo retributivo della giustizia restano esemplari le parole di Luciano Eusebi, come nel caso del recente contributo al Convegno “Giustizia riparativa e sistema penale. Evidenze di complementarità”, Università degli Studi dell’Insubria, Como, 31 ottobre 2014, www.uninsubria.it.
[4] La “fusione” o “indifferenziazione” di diritto e violenza nella sovranità della legge è – non senza ironia – accennata nel frammento 169, in cui il poeta/teologo, con riferimento al mito di Eracle, parla del nòmos basileus: «il nòmos sovrano dei mortali e degli immortali conduce con mano più forte giustificando il più violento». Il tratto ironico è intrinseco all’allusione al fatto che Nòmos è il principio sovrano, che opera «con mano più forte», nel senso di più violenta, l’unione di due opposti per eccellenza, quali sono Bìa (la violenza) e Dike (la giustizia). Il tema “diritto e violenza” è stato successivamente problematizzato da una solida tradizione, di cui alcuni punti di riferimento – tra i molti altri e limitatamente al Novecento – sono costituti da: il saggio Per la critica della violenza di W. Benjamin, in Angelus novus, Torino, Einaudi, 1962; gran parte della ricerca sulla questione del potere, condotta da Michel Foucault e la teoria di René Girard sulla violenza rituale e l’ambivalenza del sacro. Il tema, in tempi più recenti, è stato anche ripreso da angolature diverse, ad esempio con riferimento all’analisi del potere costituito e del paradosso della sovranità (come nel caso dell’opera di Giorgio Agamben) o con riferimento al dibattito sulla communitas, cioè sull’origine e sul destino della comunità, intesa come ciò che abbiamo in comune, ciò che ci unisce agli altri (è il caso dei lavori di Roberto Esposito). Inoltre, all’interno del dibattito sulla violenza della legge, sui rapporti tra individuo e società, sull’origine della comunità, su ciò che quest’ultima tiene insieme – determinandone dunque il futuro – conservano a tutt’oggi il loro valore i classici contributi di S. Freud, in particolare il tema della colpa fondativa dell’ordine sociale (Totem e tabù, 1913) e quello della rinuncia pulsionale (Il disagio della civiltà, 1929).
[5] La questione dell’utilità della pena carceraria è notoriamente oggetto di un controverso dibattito. È accertato il ben noto effetto paradosso della detenzione, che molto spesso consolida o “professionalizza” lo sviluppo di carriere criminali, invece di scoraggiarne il perpetuarsi, in accordo con l’ampia la letteratura che descrive il danno sociale prodotto da un sistema carcerario che “genera recidiva”. Ma, da un punto di vista più squisitamente concettuale, si parla di pena cosiddetta “alternativa” per addolcire il senso in sé terribile della detenzione, che è provvedimento in ampia misura inutile, vista anche la discutibilità del suo significato di minaccia, cioè di deterrent. Discutibilità ascrivibile non solo all’ancorché molto caldeggiato deficit di certezza della sanzione. Perché se almeno la pena intramuraria servisse a qualcosa – sia ai fini del recupero di chi la espia, sia per riparare il danno subito dalla parte lesa dal reato, sia come monito per dissuadere altri dall’arrecare danno al prossimo – pur rimanendo terribile, conserverebbe un’utilità. Invece, oltre che esser inumana – soprattutto nella prospettiva del rispetto dei diritti umani, anche per le ben note ragioni che rendono troppo spesso insostenibile il regime detentivo – tale pena serve solo a “perder tempo”, nel senso letterale di questo modo di dire. Non v’è dunque dubbio che il carcere configura un’espressione del male assoluto. Da qui l’idea di flettere la misura detentiva su qualcosa di diverso dal suo fondamento meramente punitivo ed espiativo. Ed ecco il lavoro cosiddetto socialmente utile. Utile al recupero – attraverso un’attività ritenuta socialmente nobile – ed utile affinché il tempo non sia solo alienazione. La punizione diviene meno acerba e l’espiazione più funzionale. Permane per molti versi un portato di violenza, connesso a valenze moralistiche: la miglior cura è il lavoro, secondo il vecchio adagio per cui “il lavoro nobilita l’uomo”. Quale miglior occupazione se non il lavoro, per porre rimedio al vizio che minaccia gli sfaccendati! Dimenticando che il lavoro criminale è anch’esso un lavoro, che richiede impegno di risorse ed abilità. E se il lavoro è alienante, o come tale percepito, per evitare di “perder tempo” ben vengano allora le attività ludiche, creative ed espressive, nonostante il rischio che facilmente può dar loro uno scacco cocente: la cosiddetta “infantilizzazione” del detenuto. Il problema resta quello di render sostenibile il trascorrere del tempo. D’altra parte, anche per i disoccupati sono previsti lavori socialmente utili, proprio per compensare il danno dovuto all’alienazione del tempo.
[6] Con quest’espressione s’intendono tutte le sanzioni correttive che non prevedono la misura carceraria, ritenendola non rispondente all’obiettivo di reintegrare il condannato nella società. Al di là dei vantaggio che offrono in termini di riduzione del sovraffollamento e dei costi di gestione del detenuto, le community based sanctions sono state valutate positivamente, in ambito anglosassone, quale strumento in grado di funzionare meglio del carcere in termini di riabilitazione e reinserimento, con ricadute positive sulla recidiva. In base all’analisi dei dati sulla recidiva, è stato dimostrato che questi programmi promuovono la sicurezza sociale, anche se tendono ad aumentare di efficacia soprattutto con condannati che non mostrano attitudini violente. Inoltre, favorendo il reinserimento sociale attraverso il coinvolgimento in attività lavorative, creano un presupposto che può contribuire al benessere sociale, rende più sostenibile il pagamento delle spesse processuali, migliora i programmi trattamentali e l’esito delle modalità riparative nei confronti delle vittime. Cioè consentono il raggiungimento di obiettivi non perseguibili se la pena viene scontata in carcere. Vi è inoltre da rilevare la prospettiva utilitaristica che le community based sanctions possono avere in termini di coesione sociale. Complessivamente, sono quattro i versanti su cui le community based sanctions sono in grado di apportare vantaggi: il superamento della sola dimensione punitiva, il valore di deterrent della detenzione, la sofferenza da deprivazione relativa al regime detentivo, la riabilitazione del condannato. Due di essi riguardano il condannato (deprivazione dovuta al regime carcerario e reale possibilità di riabilitarsi) gli altri due riguardano la dimensione sociale del reato (deterrent e superamento della sola dimensione punitiva della pena, che non offre riparazione né alla vittima specifica, né al contesto sociale nel suo complesso) www.sagepub.com/upm-data39373_1.pdf, History and Development of Community – Based Corrections.
[7] Memorabile la metafora del circo utilizzata da Tod Browning nel film intitolato per l’appunto Freaks (1932). Al di là della metafora del circo, questo tema è stato affrontato tra l’altro in un pregevole lavoro di qualche anno fa, al quale volentieri si rimanda: Leslie Fiedler, Freaks. Mostri o mutanti, scherzi di natura, incubi viventi, incarnazione delle nostre paure, caricatura delle nostre illusioni, Garzanti, Milano 1981.
[8] Per Marc Augé (Non luoghi. Introduzione a una antropologia della supermodernità, Eléuthera, Milano 1995) il luogo ha una storia ed un’identità. Ed è reso tale anche dalle persone che si relazionano ad esso e che si relazionano tra loro al suo interno. Al contrario, si possono definire “non-luoghi” i luoghi in cui le caratteristiche sopra accennate sono andate perse o non vi sono mai state. Aeroporti, centri commerciali, terminali di computer sono i non-luoghi per eccellenza ma l’espressione si può estendere alle condizioni in cui le persone che condividono uno stesso spazio non interagiscono.