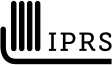“L’approccio psicologico: la condizione di vittima”
Articolo pubblicato in:
Valentini, M. (a c. di) "La tutela delle vittime di reato. Prospettive di analisi, disciplina normativa e percorsi di riforme" - Editoriale Scientifica 2021.
Vittima è colui che soffre, è colui la cui condizione esistenziale è lontana dalla possibilità di gioire della vita. Non c’è condizione più umana dell’essere vittima, come ci ricorda la maledizione biblica del partorirai con dolore e con fatica raccoglierai i frutti della terra. “Magnanimo animale/ non credo io già, ma stolto/ quel che nato a perir, nutrito in pene,/dice:- A goder son fatto, – /e di fetido orgoglio/ empie le carte eccelsi e fati e nòve/ felicità, quali il ciel tutte ignora”, ci ricorda Leopardi ne “La ginestra”. L’etimologia della parola vittima rimanda a due verbi latini: vincīre e vincere. Il primo fa riferimento all’esser legato e impedito alla fuga, ovvero la condizione dell’agnello sacrificale, colui o colei, come Ifigenia, sacrificata per consentire il realizzarsi del fetido orgoglio sopra ricordato da Leopardi. Il secondo alla condizione di chi è nella diposizione del vincitore, lo sconfitto[1], e come qui non ricordare l’Iliade e la fine dei troiani e in particolare delle donne spartite tra gli eroi Achei. Entrambe le immagini ci restituiscono il senso dell’impossibilità a sottrarsi al proprio destino che è comunque quello di soccombere, nonostante il continuo, quotidiano sforzo, riprendendo un verso della Szymborska, di far trionfare la vita sulla morte[2].
Proprio la condizione umana che accomuna tutti nel destino vittimale farebbe pensare all’inevitabile vicinanza a colui o colei che in un momento specifico è precipitato/a (l’uso di questo termine è un voluto riferimento alla sociologia vittimologica che nella seconda metà del novecento ha coniato l’espressione victim precipitation[3]) nella condizione di acuto dolore dell’esser vittima non più in senso esistenziale ma in senso più propriamente sociologico. Ebbene, questa umana vicinanza, questa capacità di compatire, ovvero di patire insieme, è assai intermittente, e se conosciamo e esperiamo molte occasioni nelle quali l’uomo è fratello all’uomo, purtroppo di gran lunga più numerose appaiono quelle in cui la fragilità dell’altro suscita desiderio di infierire, scatena violenza aggiuntiva, disprezzo o indifferenza. Alcuni sociologici o etologi hanno provato a spiegare come sia possibile che l’essere umano superi quel sentimento o istinto che tende a impedire che animali della stessa specie si aggrediscano sino a provocare la morte dell’altro parlando di peudospeciazione, ovvero di un particolare meccanismo attraverso il quale all’altro, individuo o gruppo, viene tolta l’umanità, come ci dice Romano Màdera, viene mostrificato, reso non umano e pertanto uccidibile[4]. È un processo sociale di progressiva presa di distanza che, credo, sia stato reso genialmente da Franz Kafka in “La metamorfosi”. Il giovane Gregor Sansa diviene un enorme scarafaggio e l’esito della sua convivenza in famiglia non può che risolversi con la morte dello scarafaggio e il suo finire tra i rifiuti. Rendere la genialità della scrittura kafkiana è impossibile, ma ciò che ci restituisce Kafka è il precipitare dell’altro, il diverso, il “mostro”, nella condizione che gli altri gli assegnano. La sociologia ha ben descritto di come i processi di discriminazione e inferiorizzazione vengano appresi e introiettati e costituiscano nella mente del “diverso” la condizione della propria diversità e inferiorità.
Insomma, tutto questo per dire che ci muoviamo in un campo, quello delle vittime, che dovrebbe essere familiare all’uomo. Ognuno di noi dovrebbe saper cosa voglia dire essere vittima, sentirsi vittima, magari anche solo per un momento: sentire, tutta la propria fragilità, la propria impotenza; avvicinarsi a quell’esperienza primordiale di Hilflosigkeit che Freud descrive come dato costitutivo dell’esperienza psicologica e che combina il senso di impotenza, per l’appunto, con la percezione di non ricevere aiuto, e che ci precipita in un vero e proprio sentimento di derelizione[5].
Qui è ancora Leopardi che ci ricorda come sia facile all’uomo sentire il cuore che si spaura, rimirando infiniti spazi e sovraumani silenzi. Potremmo dire che ogni attimo della nostra giornata, ogni atto previsto dal nostro vivere in comune, è pensato per sostenere il cor che si spaura nel percepire fragilità e derelizione; per consentire quello che Pascal definiva il necessario divertissement che rende possibile la vita. E purtroppo ogni gesto, ogni esperienza sociale, nel suo sostenerci nella nostra fragilità può, al contempo, renderci vittime (è paradigmatico, in questo senso, come il rimedio contro il sentimento di derelizione sia nella costruzione di affetti familiari, e come proprio lì, più frequentemente, la violenza venga agita e subita). L’intera vita umana è una fatica di Sisifo tesa a dare coraggio a chi non ce l’ha, e a sottrarglielo quando pensa di averlo acquisito. In questo senso voglio leggere i bisogni psicologici delle vittime, e in particolare delle vittime di reato. Vorrei, cioè, sottolineare come alla radice del sentirsi vittima ci sia quel senso di impotenza e di precarietà che è costitutivo della vita umana, e che, di conseguenza, i bisogni delle vittime sono in sostanza i bisogni di tutti coloro che percepiscono la prossimità tra la vita e la morte; tra il possedere qualcosa e il non possedere nulla; tra la sensazione di dominare almeno un poco la propria vita e la sensazione di essere come d’autunno sugli alberi le foglie. Le immagini contemporanee più dolenti sono certamente quelle di coloro che giungono sui barconi alle nostre coste. Hanno bisogno di essere rifocillati; abbracciati, ascoltati, confortati, orientati. Nulla per loro è dato per scontato delle certezze di cui ogni essere umano si circonda.
E quindi, per le vittime di reato, su cui tornerò per fornirne la definizione proposta dalla Direttiva europea 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, le cose non stanno diversamente, ancorché le dimensioni traumatiche, i livelli di fragilizzazione o il sentimento di derelizione non necessariamente debbono assumere quelle dimensioni e talvolta possano essere anche molto modesti. La stessa Direttiva sopra ricordata indica, di fatto, i medesimi bisogni a cui l’intervento con le vittime deve rispondere: di ascolto, di informazione, di orientamento, di sostegno psicologico e sociale, di protezione dai rischi di rivittimizzazione che il coinvolgimento nei procedimenti giudiziari oggi, sovente, produce.
E tuttavia, nel caso delle vittime di reato ci troviamo all’interno di un processo storico-sociale di più ampia portata e che a mio parere deve essere preso in considerazione per una giusta comprensione anche delle condizioni sociali e psicologiche in cui si colloca l’esperienza di vittimizzazione.
Ma cosa è un reato? Ci possiamo limitare a ciò che i codici definiscono essere tale? Non abbiamo qui il tempo di affrontare un tale argomento se non per richiamare l’attenzione sul carattere socialmente e storicamente determinato di ogni definizione giuridica di reato. Per semplicità, però, e per il senso del nostro argomentare, preferiamo definire reato ciò che nell’esperienza individuale e nel contesto sociale è inteso contravvenire le regole del buon vivere civile o del vivere in comune. Ovviamente questa non ne costituisce una definizione giuridica e, tuttavia, intende richiamare alla mente le tante pagine scritte per ricordare come, a seguito di una trasgressione operata, via sia una sorta di “naturale” necessità di ripristinare l’ordine turbato. I sentimenti di vendetta della vittima e il bisogno di ripristinare il giusto ordine delle cose (il kósmos[6]) rappresentano così le due fonti che generano l’esigenza di sanzionare chi ha trasgredito. Semplificando ulteriormente possiamo dire che, a seguito di un reato, si dà il bisogno di agire, spesso punendo il trasgressore, per una intrinseca esigenza umana e per un dovere verso la divinità. Questa esigenza sociale, che potremmo anche chiamare vendetta, è profondamente radicata nelle coscienze e nella società, e genera una costante richiesta di giustizia, intesa sovente, come più severa sanzione per il reo. Come sappiamo questa richiesta di giustizia è anche sostenuta dal senso di insicurezza che la non punizione del reo produce, generando l’impressione che non sanzionando il reo saremmo nelle mani dei violenti, dell’abuso e dell’arbitrio, dell’akosmía appunto.
Il buon funzionamento della società dipenderebbe così dalla giusta punizione di chi trasgredisce. Sono, però, più di duemila e cinquecento anni che la nostra società – e quindi anche i singoli individui – è chiamata a ripensare il senso della pena e a riattribuire la responsabilità di ripristinare l’ordine naturale. La sofferenza del singolo e il suo bisogno di vendetta deve lasciare il passo a bel altri valori sociali: il bisogno di recuperare il reo; il senso della pietas e del perdono; la consapevolezza che è allo Stato il compito di ripristinare l’ordine. Sentimenti quali la rabbia, il pretendere rottura per la rottura, occhio per occhio, dente per dente, debbono essere controllati e in un certo senso elaborati senza scadere nella rassegnazione, poiché la rassegnazione costituirebbe l’evidenza di un fallimento dei sistemi sociali di proteggere i loro cittadini che è anche uno dei bisogni primari[7] degli esseri umani in generale e ancor più di chi ha subito reato.
Chi non ricorda l’ira di Achille che tanti lutti arrecò agli Achei? L’ira per un torto subito, forse un reato. Ebbene, quell’ira non può e non deve trovare spazio. L’iroso Achille deve divenire il saggio Enea: questo il primo compito psicologico. Affidarsi allo stato e imparare che, ancorché il fato ha voluto che egli fosse fatto vittima, non sua è la responsabilità di ripristinare l’ordine delle cose e né sua sarà, in verità, la gioia della giustizia, se di gioia si può parlare. E se questo affrancamento solleverà il povero e il fragile da un compito troppo gravoso per le sue piccole spalle, soprattutto quando il reato è compiuto da qualcuno tanto più forte, e qui come non pensare al povero Renzo Tramaglino, ciononostante rimane un senso di incompiutezza tanto più grande quanto maggiore sarà il dolore subito, e tanto maggiore sarà il biasimo[8] per non avere, eventualmente, garantito la punizione esemplare del reo.
Quello che vogliamo dire è che, oltre alla sofferenza psicologica e sociale di chi ha sentito precipitarsi nella condizione di vittima, e quindi ha subito quello che ha tutti gli effetti costituisce un trauma psicologico di cui la condizione di Hilflosigkeit rappresenta l’epitome, colui che ha subito un reato ha un lavoro psicologico in più da compiere, poiché è posto di fronte al tema della giustizia e dell’ordine delle cose; della responsabilità individuale e sociale; della rivolta e della rassegnazione: dell’ira e della pietà; del fidarsi della società e delle istituzioni o del sentirle false e ingiuste. È indubbio, infatti, che, come ci illumina la psicoanalisi, ognuno di noi ha introiettato una propria struttura morale, che la psicoanalisi chiama super-io, In cui quell’esigenza di sanzione verso chi trasgredisce è parte significativa, ivi compreso quando il trasgressore siamo noi stessi, come ci insegna Sigmund Freud ne “Il criminale per senso di colpa”[9] o, ancor più magistralmente, Dostoevskij in “Delitto e castigo”. L’incontro con l’evento reato è anche l’incontro con il nostro Super-Io e con la nostra interna necessità di giudicare, punire, assolvere. Orbene, colui che ha subito un reato, o ritiene di averlo subito, vede attivarsi al suo interno una quantità di sentimenti anche molto arcaici: paura, umiliazione, ira, senso di derelizione, esigenza di vendetta, aspettativa di giustizia. Questo insieme di sentimenti hanno oggi necessità di essere controllati, elaborati e talvolta repressi. Questo lavoro può essere facilitato o ostacolato dal contesto sociale e dalle istituzioni: si può percepire attenzione, solidarietà, sostegno, o, al contrario indifferenza, biasimo o persino ostilità. Di certo il sistema di giustizia, come ben ci dicono tutti gli studi di vittimizzazione secondaria, è il meno adatto a aiutare chi è stato vittima: è soprattutto la promessa di giustizia, poi, che rischia di essere un messaggio fallace e fortemente disturbante. Infatti non è la vittima che dovrà gioire per l’eventuale giustizia fatta, e soprattutto i tempi della giustizia sono così dilatati mentre l’onda d’urto di questa congerie di sentimenti interessa la vittima soprattutto nell’immediatezza del fatto. Ecco perché la Direttiva europea 2012/29/UE, e la successiva adozione della medesima nel nostro codice[10] riconosce quale vittima di reato chiunque ritenga di aver subito un reato, senza bisogno di attendere l’esito di un processo che accerti la verità giuridica del fatto.
Giungiamo così, in estrema sintesi, a cercare di offrire alcuni spunti su di un tema, quello delle vittime di reato che, necessariamente, si pone al punto di incontro tra riflessione sul senso del sistema penale e sulle modalità di costruzione di comunità più eque e coese. La risposta sociale al reato ha sin qui privilegiato l’attenzione al reo in termini di prevenzione, punizione e recupero: tale approccio ha messo in evidenza tutta la fragilità dei sistemi di law enforcement, chiamati a un’azione sempre più repressiva e sempre meno efficace, che ha suscitato sentimenti di grande delusione nella pubblica opinione e quasi il bisogno delle vittime di un maggior protagonismo sia nelle aule di tribunali sia, cosa ancor più pericolosa, evocando un’ autonoma voglia di giustizia. È per tale motivo che la direttiva sopra ricordata si sforza di porre una nuova e più cogente attenzione alle vittime di reato, comprendendo che la vittima si trova a scontrarsi con un sistema di law enforcement sempre più disattento e rivittimizzante e che tende a banalizzarne l’esperienza di dolore e frustrazione sociale; in un contesto sociale ostile, aggressivo, vendicativo che non aiuta né ha superare il dolore né a dismettere il bisogno di vendetta; e soprattutto sempre più sola in ragione di reti sociali sempre più sfrangiate e instabili. In questa condizione non possono che aumentare i sentimenti ostili verso la società; la rabbia e l’insoddisfazione verso i sistemi di law enforcement; la rassegnazione e l’isolamento sociale. Questa piccola riflessione, così, pur giungendo da un clinico non intende porre l’accento sulle competenze cliniche necessarie per dare sostegno e cura a chi è sicuramente vittima di un’esperienza traumatica, quale quella prodotta da un reato, quale che sia la gravità del trauma. Ma vuole segnalare che mai come in questo caso parlare di benessere psicologico significa porsi un problema di ordine psico-sociale che si colloca all’intersezione tra politiche sanitarie, politiche sociali, e politiche culturali tese a ripensare il ruolo sociale della vittima. Nelle azioni di ascolto, informazione, sostegno psicologico che le vittime di reato necessitano sin da subito, ovvero nell’immediatezza dell’evento, è indispensabile tenere a mente che oltre alla psicologia del trauma, al senso di derelizione che sempre il sentirsi vittima comporta, vi è un più complesso lavoro psichico che ha a che fare con il senso stesso di giustizia, con il senso della colpa e del perdono, con le arcaiche figure che reggono i meccanismi del premio e della punizione, e che possono divenire persecutorie e inflessibili o, al contrario, collassare rovinosamente. Non è un caso che i primi segnali del movimento culturale che ha richiamato la necessità di una maggiore attenzione alla vittima giungano da coloro che hanno guardato con occhio critico al funzionamento dei sistemi penali, in particolare, ma non solo, sostenendo la necessità di un profondo ripensamento delle categorie del danno e dell’offesa, attraverso l’istituzione di pratiche di Giustizia ripartiva[11], anche nella prospettiva di aiutare la vittima a far almeno una parte di quel lavoro psicologico di cui si diceva. Purtroppo troppo poco si fa ancora in questo senso, e quindi anche la ricerca non è ancora in grado di dire di più su quanto una patologia sociale così mal gestita come il dolore delle vittime di reato possa essere causa di disastri psicologici e contribuire a rendere ancora più fragili i legami sociali.
NOTE:
[1] S. Vezzadini, Per una sociologia della vittima, Franco Angeli, 2012, p. 89.
[2] W. Szymborska, Sulla morte senza esagerare in 25 Poesie, Arnoldo Mondadori, 1998.
Non c’è vita / che almeno per un attimo / non sia stata immortale. / La morte / è sempre in ritardo di quell’attimo. / Invano scuote la maniglia /d’una porta invisibile. /A nessuno può sottrarre / il tempo raggiunto.
[3] In realtà con “victim precipitation” si fa, in letteratura, riferimento al percorso vittimologico che, a partire dagli studi statunitensi di Wolfgang sugli omicidi a Philadelphia tra il 1948 e il 1952, ha in qualche modo condotto al processo di colpevolizzazione della vittima di un crimine per aver compartecipato a produrlo, in ragione dei suoi comportamenti, del suo stile di vita, ecc. M.F. Wolfgang, Victim Precipitated Criminal Homicide, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science Vol 48 May-June 1957 No. 1, p. 1. Qui invece si utilizza lo stesso termine in riferimento al precipitare della vittima in una condizione di sofferenza e del bisogno di protezione dalla sensazione di derealizzazione e annichilimento che l’esperienza di vittimizzazione produce.
[4] R. Màdera, Dalla pseudospeciazione al capro espiatorio, in: AA.VV., Tabula rasa. Neuroscienze e culture, Fondazione Intercultura, vol. 15, 2019.
[5] S. Freud, Compendio di Psicoanalisi, 1938, Biblioteca Bollati Boringhieri, 2020.
[6] «Colpa» (adikía) e «pena» (díke) costituiscono una relazione indissolubile, come espressioni di una dinamica interna e una totalità intesa come kósmos. Ove alla colpa non si facesse corrispondere la pena, inevitabilmente il kósmos finirebbe per cadere ad akosmía. (…). Inconcepibile sarebbe – in quest’ottica – lasciare aperta la «ferita» determinata dall’ingiustizia. Di qui discende dunque da un lato la funzione di «risanamento» svolta dalla pena e dall’altro l’obbligatorietà della sanzione stessa. U. Curi, Il Colore dell’Inferno, La pena tra vendetta e giustizia, Bollati Bolinghieri 2019, p. 89.
[7] Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985 l’Assemblea Generale dell’ONU dichiara i Principi base della Giustizia per le Vittime di crimini e di abusi di potere
[8] Si pensi a come la sensazione di non aver dato seguito alla vendetta del padre abbia tormentato la mente dell’Amleto di Shakespeare come di quella di Oreste, protagonista della Trilogia di Eschilo, a cui la sorella Elettra chiede di vendicare la morte del padre Agamennone.
[9] S.Freud, Alcuni tipi di carattere tratti dal lavoro psicoanalitico, in Opere di Sigmund Freud (OSF), Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917, Torino, Bollati Boringhieri, 2002. vol. 8.
[10] L’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE con il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016.
[11] G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffré Editore, 2003