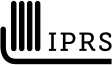La presa in carico psicosociale dei richiedenti e titolari di protezioni internazionali
A cura di Raffaele Bracalenti e Attilio Balestrieri
Questo Report raccoglie alcune considerazioni in merito alla possibilità di migliorare la qualità del lavoro delle strutture per l’accoglienza dei migranti. Considerazioni che discendono da quanto osservato: a) nel corso delle visite presso i CIE di Torino e Roma, i CAS di Torino-Alpignano, Milano-Via Corelli e Brindisi – Gravignano e lo SPRAR di Agrigento; b) nel corso del confronto con alcune figure di operatori che in esse strutture sono impegnati e c) nel corso delle giornate di studio che hanno avuto luogo presso l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel giugno 2017 (v. link).
Più in particolare, questo Report propone alcune considerazioni relative esclusivamente al lavoro nei CAS e dei CAS. Come anche più avanti descritto con maggior dettaglio, analoghe considerazioni relative ai CIE ed allo SPRAR, a ragione delle specificità di queste diverse tipologie di strutture, costituiranno l’oggetto di altri Report ad hoc.
Il sistema per l’accoglienza in Italia: evoluzione, normative, assetti e numeri
Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati ha conosciuto in Italia significative trasformazioni, in particolare a partire dal 2011, anno in cui fu proclamata dal Governo la cosiddetta “Emergenza Nord Africa” (Ena). Prima di illustrare la sua attuale configurazione, è opportuno ricordare che in quell’anno, per far fronte agli arrivi di circa 62.000 persone dall’Africa settentrionale ed orientale, fu predisposto un sistema di accoglienza straordinario coordinato dalla Protezione Civile, che affiancò il circuito dei Centri di Accoglienza governativi per Richiedenti Asilo (Cara) e quello ordinario rappresentato dalla rete del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar). Un’ulteriore trasformazione è stata inaugurata all’inizio del 2014, quando il nuovo aumento degli arrivi di richiedenti asilo, in un contesto di saturazione dei Cara e dello Sprar, ha indotto il Ministero dell’Interno ad incaricare le Prefetture dell’attivazione di Centri di Accoglienza Straordinari (Cas). Dall’8 gennaio 2014 a tutt’oggi, con un susseguirsi di numerose circolari ministeriali, il Viminale ha continuato a richiedere alle Prefetture l’ampliamento del sistema di accoglienza straordinario.
Ciò è avvenuto nonostante l’obiettivo di superare la logica emergenziale nelle politiche di accoglienza sia stato assunto in modo strutturale nel “Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari”, adottato in sede di Conferenza Unificata dal Governo, dalle Regioni e dagli enti locali il 10 luglio 2014. Di fronte ai significativi arrivi di migranti registrati nel 2014, l’intesa si propose infatti, almeno a livello programmatico, di sviluppare una collaborazione inter istituzionale tra Governo, Regioni, Province e Comuni e di strutturare il sistema di accoglienza in tre livelli (primo soccorso e accoglienza, prima accoglienza e seconda accoglienza). Si considerava infatti che “la gestione dell’accoglienza diffusa, tramite le prefetture e senza il coinvolgimento dei territori, rischia di creare disagi e tensioni”. Oltre all’aumento delle risorse destinate al mantenimento del sistema, l’accordo prevedeva, in corrispondenza dei nuovi flussi, una distribuzione dei migranti su tutto il territorio nazionale seguendo criteri di ripartizione regionale commisurati alla quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali. Parallelamente, a partire dal luglio 2013, era intanto iniziato il processo di ampliamento della rete Sprar, gestito sia tramite la richiesta di “posti aggiuntivi” di accoglienza rivolta agli enti locali già aderenti alla rete, sia attraverso la pubblicazione di bandi pubblici finalizzati a consentire la presentazione di nuovi progetti.
Una modifica molto più rilevante del sistema di funzionamento dello Sprar, potenzialmente suscettibile di porre finalmente le basi per il consolidamento di un sistema di accoglienza ordinario e omogeneo sul territorio nazionale è, nei fatti, recentissima.
A seguito dell’approvazione, il 13 maggio 2015, dell’Agenda europea sull’immigrazione da parte della Commissione Europea, della conseguente adozione da parte del Governo italiano di una Road map e dell’approvazione del Dlgs. 142/2015, entrato in vigore il 30 settembre 2015, il sistema di accoglienza è stato delineato come di seguito descritto in dettaglio.
I Cpsa e gli Hot-spot
Il primo livello è quello del primo soccorso e assistenza prestato nelle zone maggiormente interessate dagli sbarchi. Qui dovrebbero essere offerti i servizi di primissima accoglienza, realizzato un primo screening sanitario e svolte le attività di identificazione dei migranti. Questa funzione rimane, in base all’art.8, in capo ai Cpsa (Centri di Primo Soccorso e Assistenza) istituiti dalla legge 563/1995, meglio nota come legge Puglia. In realtà con l’adozione della Road map, a tali centri si sono sovrapposti gli Hot-spot, strutture volute dalla Commissione Europea. Oggi sono operativi quelli di Lampedusa (ex Cpsa), Taranto, Pozzallo e Trapani (ex Cie). Si tratta di strutture la cui funzione precipua è quella di identificare i migranti e di selezionare le persone che intendono richiedere protezione internazionale rispetto ai cosiddetti migranti economici.
I centri di prima accoglienza (o hub)
L’art. 9 del Dlgs. 142/2015 disciplina i “Centri di prima accoglienza”, che svolgono la funzione di accogliere i cittadini stranieri già sottoposti alle procedure di fotosegnalamento, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di identificazione, la definizione del loro status giuridico, la verbalizzazione della domanda di asilo e l’avvio della procedura di esame della domanda. Si tratta di strutture regionali o interregionali che nel Piano approvato il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata erano denominate hub: le persone possono uscire dai centri nell’orario diurno. Per il loro approntamento è previsto l’utilizzo anche di ex caserme; la loro gestione può essere affidata a “enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di Comuni, a enti pubblici o privati che operano nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell’assistenza sociale”. I 16 Cara governativi esistenti dovrebbero essere destinati a svolgere questa funzione. Si ricorda che i Cara sono stati istituiti nel 2002 con la denominazione di Centri di Identificazione e Asilo e che l’attuale denominazione si deve al Dlgs. n. 25/2008. Si tratta di strutture preposte all’accoglienza di persone che hanno già manifestato la volontà di chiedere asilo, per il tempo necessario a effettuare le procedure di identificazione e formalizzare la domanda di protezione internazionale.
I centri Sprar
L’art. 14 Dlgs. 142/2015 identifica il sistema di seconda accoglienza territoriale con lo Sprar, stabilendo che possano accedervi i richiedenti asilo che ne facciano richiesta, purché abbiano già formalizzato la domanda di protezione e non dispongano di un reddito sufficiente (identificato con l’importo dell’assegno sociale).
Lo Sprar, è costituito da una rete di enti locali che, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, promuovono progetti di accoglienza integrata finalizzata all’inserimento sociale ed economico dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. Nel 2015 lo Sprar si è articolato in 430 progetti territoriali promossi da 339 Comuni, 29 Province e 8 Unioni di Comuni in 10 Regioni.
Le strutture temporanee (o Cas)
Nel caso in cui si verifichino “arrivi ravvicinati e consistenti di richiedenti” e non sia possibile accoglierli nei centri di prima accoglienza o nella rete Sprar, l’art.11 del Dlgs. 142/2015 prevede l’approntamento di misure straordinarie di accoglienza in “strutture temporanee” su disposizione delle Prefetture, “sentito l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura” e con regolare procedura di gara pubblica. Ma nei casi di estrema urgenza, è consentito il ricorso a procedure di affidamento diretto.
Il trattenimento nei Centri di Identificazione ed Espulsione
Oltre a delineare il sistema di accoglienza, il dlgs. 142/2015, Art. 6, inasprisce le ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di Identificazione ed Espulsione portando il periodo di permanenza massima a 12 mesi. Il trattenimento può essere disposto dal Questore quando il richiedente protezione internazionale ha commesso reati gravi; costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o è considerato pericoloso socialmente; ha presentato la domanda dopo essere stato colpito da provvedimento di espulsione trovandosi già in stato di detenzione oppure è considerato a “rischio di fuga”.
| Presenze nelle strutture di accoglienza in Italia all’11.10.17 (per lo Sprar al 12.9.17) | ||||
| Strutture temporanee (CAS) | CPSA e
HOT-SPOT |
Centri di prima accoglienza (HUB) | SPRAR
(al 12.9.17) |
Totale |
| 126.584 (77%) | 1.138 (1%) | 13.996 (9%) | 22.192 (14%) | 163.910 (100%) |
Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno l’11 ottobre 2016, le persone accolte sono complessivamente 163.910. Di esse, il 77% è accolta nei CAS-Centri di accoglienza temporanea.
L’assetto attuale
Con l’approvazione definitiva da parte dell’aula della Camera dei Deputati, del disegno di legge già approvato dal Senato, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, che contiene “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.
L’atto introduce una serie di misure, tra cui: semplificazione ed accelerazione dei tempi delle procedure relative alla richiesta di protezione internazionale, anche attraverso l’abolizione del secondo grado di giudizio in caso di rigetto dell’istanza, ferma la possibilità di ricorso in Cassazione, e il potenziamento delle strutture giudiziarie con l’istituzione, presso i tribunali, di 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea; assunzione, da parte del Ministero dell’Interno, di 250 unità di personale altamente qualificato da destinare alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza o nel circuito della rete Sprar sono iscritti all’anagrafe della popolazione residente e possono svolgere volontariamente, a titolo gratuito, attività di utilità sociale a favore della collettività locale nel quadro delle normative vigenti; identificazione nei “punti di crisi” all’interno delle strutture di prima accoglienza dei cittadini stranieri soccorsi durante operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in caso di attraversamento della frontiera, con contestuale informazione su protezione internazionale, ricollocazione in altri Stati Ue e possibilità di rimpatrio volontario assistito, è altresì previsto il trattenimento in caso di “rifiuto reiterato” di sottoporsi all’identificazione; i centri di identificazione ed espulsione diventano centri di permanenza per i rimpatri, in tutto il territorio nazionale, monitorati quotidianamente, con accesso libero per gli stessi soggetti ammessi a visitare le carceri; contrasto all’immigrazione illegale anche attraverso un Sistema Informativo Automatizzato (Sia) monitorato dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero, interconnesso con altri sistemi informativi tra i quali il Sistema informativo Schengen; rito abbreviato nei giudizi sui provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e per motivi di prevenzione del terrorismo; rimpatri con iter più veloci, puntando sulla cooperazione con i paesi di provenienza attraverso accordi bilaterali.
Tali disposizioni non si applicano ai minori stranieri non accompagnati, per i quali è stata approvata di recente in via definitiva dalla Camera la normativa che introduce in linea generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minorenni.
Una precisazione preliminare: il presente Report non può concentrare la propria attenzione sui CIE, a ragione delle loro caratteristiche
È utile premettere che i CIE-Centri di identificazione ed espulsione, prima denominati CTP-Centri di permanenza temporanea, sono previsti dalla legge italiana per trattenere gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera, nel caso in cui il provvedimento non sia immediatamente eseguibile. Come dire che il trattenimento consiste nella privazione della libertà di cittadini stranieri per ragioni legate al loro status migratorio (condizione di ingresso e soggiorno irregolare). In molti casi anche i richiedenti asilo sono trattenuti in questi centri al fine di essere rimpatriati. Non si tratta dunque di strutture per l’accoglienza, bensì di luoghi da cui le persone, ancorché definite “ospiti” e non già “detenuti”, non possono uscire liberamente. Questa precisazione per dire che certamente nei CIE, a ragione di tali loro specificità, sono assai limitate le possibilità di progettare interventi di promozione del benessere psicosociale finalizzati alla tutela della salute mentale. Oltre all’estrema disomogeneità dei soggetti che vi sono ospitati – disomogeneità di profili, storie e traiettoria, come nel caso osservato a Torino – sussistono evidenti limiti operativi dovuti sia al fattore tempo (l’imprevedibile durata della permanenza di ciascun “ospite” nella struttura) sia ai vincoli imposti dal regime di sicurezza che informa la gestione di queste strutture (impossibilità di introdurre materiali, strumenti, risorse umane e quant’altro all’interno del CIE).
Per queste ragioni, nel presente Report non si parla delle possibilità di migliorare la qualità del lavoro dei CIE. Allo stesso modo, l’attenzione di questo Report non si concentra sulle strutture SPRAR, a ragione delle loro specificità. Il lavoro dei CIE e nei CIE, nonché il lavoro dello SPRAR e nello SPRAR, saranno oggetto di altri documenti ad hoc.
I motivi dell’interesse specifico di questo Report per i CAS
Le strutture a cui sono principalmente rivolte le considerazioni oggetto del presente Report sono i CAS-Centri di accoglienza straordinaria, istituti – come si diceva – al fine di sopperire alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie di prima accoglienza o nei servizi predisposti dagli enti locali, in caso di arrivo consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo. Quest’ultima eventualità, come risaputo, da tempo rappresenta la norma più che l’eccezione, tant’è che al momento i CAS costituiscono una sorta di modalità ordinaria di accoglienza, come peraltro confermano i numeri prima proposti in tabella. La permanenza nei CAS dovrebbe essere temporalmente definita, nel senso di limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento degli ospiti nel sistema di seconda accoglienza, anche a seconda dell’esito del lavoro della Commissione che esamina la richiesta di protezione.
Nel riassumere l’evoluzione e l’assetto del sistema di accoglienza in Italia si è visto che sono previste strutture destinate al semplice “ricovero” di persone che giungono in Italia in gran numero ed alla loro identificazione. I CAS si pongono al livello immediatamente successivo, alla stregua di “strutture intermedie”, destinate alla prima accoglienza. Vi sono infine le strutture Sprar, riservate a coloro che, in virtù dell’acquisizione di uno status di rifugiati meglio definito, hanno diritto di rimanere in Italia e debbono essere accompagnati lungo un percorso di integrazione. Si è parlato dei CAS come strutture “intermedie” per dire che la permanenza in esse dovrebbe esser riservata a coloro che vivono in quella condizione “di limbo”, determinata dall’attesa che la Commissione si esprima in un senso o nell’altro (in merito alla richiesta di asilo) oppure, in aggiunta ed eventualmente, dovrebbe essere riservata ai ricorrenti, ove l’esito della richiesta non sia stato favorevole. Questa situazione transitoria ed incerta solleva molti interrogativi sul senso di queste strutture.
In prima battuta si potrebbe persino trarre la conclusione che l’intero sistema sia strutturato in centri di serie A (lo Sprar) e centri di serie B (i CAS). Centri di serie B perché dedicati a soggetti a che non hanno ancora acquisito la pienezza del titolo di permanenza in Italia e potrebbero non acquisirla mai. Qual è dunque il senso da attribuire al CAS, quale il suo assetto e quale il ruolo che esso è chiamato a svolgere? Deve in qualche modo servire a “formare”, “sagomare”, “orientare” le persone che vi accedono, in modo da gettare le premesse per un possibile percorso di integrazione, pur se nell’incertezza dell’esito della richiesta di asilo, che potrebbe risultare negativo e condurre invece all’eventualità del rimpatrio? O deve il CAS avere la mera funzione di tener “parcheggiati” i migranti finché la Commissione esaminatrice non si pronuncia in merito all’esito della richiesta? Di fronte a questa domanda, questo Report risponde affermando di potere ritenere che il CAS vada inteso come struttura di sostegno all’integrazione a pieno titolo. Per numerose ragioni di seguito specificate.
I tempi di permanenza nella struttura sono lunghi e, anche per una elementare incompatibilità con la prospettiva dei diritti umani universali, non è opportuno lasciare queste persone in uno stato di sospensione per un intervallo così prolungato (non si può “sottrarre” indebitamente un anno di vita ad un essere umano).
Anche nel caso di esito negativo della richiesta dello status, qualora alcune persone vadano incontro alla prospettiva del rimpatrio, dopo essere rimaste in struttura per un periodo di tempo certamente non breve, se al momento del rimpatrio hanno incrementato – grazie alla permanenza nel CAS – il proprio bagaglio formativo, di competenze e capacità di intraprendere, saranno probabilmente in condizioni di potere agire come attivatori ed inserirsi meglio nei contesti di origine o di partenza. Come dire che, persino in caso di esito negativo della richiesta, il CAS può servire a dar luogo ad un investimento che in ogni caso è opportuno promuovere.
Quindi il CAS può essere inteso come segmento rilevante del sistema di accoglienza, quale che sia il senso che la parola accoglienza può assumere. Allo stesso modo, il lavoro svolto all’interno dei CAS prescinde in ampia misura dal pronunciamento della Commissione esaminatrice la richiesta di riconoscimento dello status. E vale su quest’ultimo punto porre l’accento perché si è osservato che in molti casi gli operatori sono messi in difficoltà dal fatto che il loro lavoro potrebbe esser “vanificato” da un eventuale rigetto dell’istanza avanzata dal migrante. Tant’è che, a volte, gli operatori – per molti versi in maniera analoga a quanto si verifica per gli ospiti della struttura – si sentono come “demoralizzati” quando quest’eventualità si verifica. Ed è perciò importante ribadire che gli operatori siano sempre e pienamente consapevoli dell’importanza del loro lavoro e riescano a lavorare quasi “dimenticando” l’alea del responso della Commissione esaminatrice, poiché la permanenza del migrante nel CAS non va intesa riduttivamente come mero momento di passaggio in attesa dell’esito della richiesta di riconoscimento dello status, bensì come tempo “pieno”, fatto di costruzione di opportunità, impostazione di percorsi e ridefinizione di prospettive, che sono anche indipendenti dal destino del migrante che ne beneficia, sia laddove la sua prospettiva sia quella dell’integrazione, sia laddove la sua prospettiva sia quella del rimpatrio.
In sintesi, vi sono più ordini di ragioni che conferiscono estrema rilevanza al lavoro del CAS e nel CAS. In primo luogo ragioni che riguardano direttamente il tema del rispetto dei diritti umani fondamentali, per cui è dovere universale garantire condizioni di sicurezza e di adeguata permanenza a queste persone, soprattutto in fase di prima accoglienza, sebbene di tratti di persone il cui status giuridico non è ancora definito. E per le stesse ragioni è doveroso garantire condizioni di vita adeguate ed attività utili a persone che trascorrono un periodo non breve della propria vita in questa condizione di limbo. Proprio per non sottrarre loro, del tutto indebitamente molti mesi di vita.
Vi sono poi ragioni più specifiche, riconducibili all’area del diritto alla salute, che riguardano la prevenzione dell’elevato rischio di disagio mentale dovuto per l’appunto alle condizioni di vita all’interno delle strutture per l’accoglienza, sul quale la letteratura scientifica ha ampiamente posto l’accento, parlando di promozione del benessere psicosociale. Come più volte qui ricordato, la promozione del benessere psicosociale attraverso attività volte all’orientamento ed alla riformulazione di un progetto migratorio, a prescindere dagli esiti della richiesta di riconoscimento dello status, costituisce anche lo strumento principe ai fini della prevenzione, riabilitazione e cura della salute mentale di queste persone.
Nondimeno vi sono ragioni di ordine strategico, nel senso di investimento di risorse, perché le attività di orientamento e riformulazione del progetto migratorio realizzate dal CAS e nel CAS incrementano il patrimonio di competenze e capacità di intraprendere dei migranti, mettendoli in condizioni di poter agire come attivatori ed inserirsi meglio nei contesti di origine o di partenza, anche nel caso di pronunciamento sfavorevole da parte della Commissione esaminatrice.
Posto ciò, si ritiene inoltre che per molti verso proprio il CAS costituisca il segmento più importante del percorso di accoglienza, perché è quello in cui, data l’incertezza connessa alla condizione di limbo che caratterizza il migrante qui ospite, più elevato può essere il rischio per la salute mentale, dunque il cumularsi di elementi e fattori di sofferenza. E data sempre la fase di incertezza e ciò che ne consegue in termini di “capacità di tenuta” del migrante, per l’appunto nella fase di permanenza nel CAS è più elevato il rischio di disperdere le opportunità formative a favore di quei migranti che hanno più probabilità di transitare nello Sprar. Per costoro, una volta disperse le opportunità che proprio il CAS può fornire, è più elevato il rischio di passare in fase di seconda accoglienza in condizioni di fragilità, cioè in condizioni che rendono più complesso il lavoro dello Sprar, ovvero non consentono allo Sprar di svolgere al meglio la propria funzione.
È a questo punto chiaro che nel CAS si ha la preziosa opportunità di effettuare la prima vera e propria presa in carico del migrante, che a sua volta rappresenta il momento che segna il rapporto del migrante sia con la struttura stessa, sia col contesto di arrivo. Come dire che è della massima rilevanza lavorare sul CAS e nel CAS, soprattutto nella fase iniziale dell’incontro tra il nuovo arrivato e la struttura, che conferisce una vera e propria “cifra” al rapporto.
Il CAS tra “non luogo” e luogo dell’accoglienza
Il CAS rappresenta per molti versi la prima porta di accesso al percorso che il migrante può compiere in Italia. Come dire che in queste strutture si ha l’opportunità per impostare – per alcuni versi silenziosamente, per altri versi palesemente; per alcuni versi esplicitamente per altri versi implicitamente – l’assetto del cammino, del viaggio o dell’avventura che ciascuna persona potrà o saprà percorrere nel contesto di arrivo. Del resto, non solo la tecnica psicoanalitica – e psicoterapeuta in genere – riconosce l’importanza fondamentale della prima seduta, del momento di esordio o del primo incontro tra analista ed analizzando ai fini della corretta impostazione dell’intero lavoro terapeutico e, in ampia misura, ai fini del suo successo. È anche sapere comune che partire col piede giusto, cioè costruire fin da subito le premesse per un buon lavoro, ha grande rilevanza nel determinare l’esito favorevole di qualsiasi impresa. Dunque il momento del primo ingresso è quello più favorevole per gettare le basi di un rapporto costruttivo – ovvero le basi di un’interazione positiva – non solo tra migrante e struttura per l’accoglienza, bensì tra migrante e paese d’arrivo.
Il CAS, in quanto luogo della prima accoglienza, dunque del primo incontro, rappresenta la sede elettiva per impostare correttamente un percorso, visto che per l’appunto qui i percorsi possibili prendono le mosse. Ma oltre a ciò, il CAS è anche il luogo in cui il migrante transita, nel senso che vi permane temporaneamente, cioè per un tempo la cui durata è variabile ma in ogni caso definita. Ed è proprio la durata della permanenza – certamente variabile a seconda dell’andamento e dell’esito di un iter burocratico ma comunque transitoria – che definisce una cornice temporale, cioè un tempo limitato, in cui può aver luogo l’impostazione di un processo di progressiva autonomizzazione, che proseguirà nello Sprar o in maniera anche diversa. Come dire che la durata temporanea della permanenza – non breve ma nemmeno infinita – determina nel luogo migliore (quello in cui avviene il primo incontro) il momento ideale (il tempo definito) per costruire le possibilità di integrazione del migrante. Il CAS viene dunque a costituire sia un luogo, sia un momento, entrambi preziosi.
Anche la tradizione omerica – intesa come uno degli emblemi delle plurimillenarie culture che affacciano sul Mediterraneo ed intorno ad esso si sono sviluppate – descrive il luogo e le caratteristiche dell’accoglienza. In particolare, il mito dell’incontro con i Feaci:
Venne un’ancella a versare lavacro da brocca
bella, d’oro, su un bacile d’argento,
ché si lavasse; e avanti gli trasse una mensa pulita:
pane la dispensiera fedele venne a portare,
molti cibi servendo, larga di quello che c’era.
Così beveva e mangiava il costante Odisseo luminoso.
A quanti voi conosciate fra gli uomini, che il colmo dei mali
trascinano, a questi per le mie pene potrei avvicinarmi,
e io forse più mali ancora potrei raccontare,
tant’è la somma dei mali che per volere dei numi ho patito.
Ma lasciate che io ceni, pur così afflitto
(Odissea, libro VII, 172-215)
Come un riff sul tema del lavoro psico-sociale
La trasformazione dei flussi migratori e la diversa configurazione dei fattori di rischio che ne deriva hanno imposto anche alla ricerca scientifica, oltre che all’impegno degli operatori, la necessità di attrezzarsi per affrontare un passaggio.
Il passaggio da un’accoglienza per “migranti economici” verso un’accoglienza emergenziale, incentrata sull’esigenza primaria di garantire la promozione del benessere psico-sociale di migranti. Tenendo presente – come in parte già accennato – anche il fattore di rischio connesso alle stesse condizioni di vita all’interno delle strutture per l’accoglienza.
Ed è questa la ragione per cui l’attenzione della ricerca scientifica si è concentrata sulla definizione delle modalità – o delle caratteristiche – in grado di assicurare un buon grado di efficacia ed efficienza all’insieme di azioni che sostanziano la prima accoglienza, in modo da renderla funzionale alle esigenze dei migranti, anche con riguardo al loro bisogno di tutela della salute mentale.
Nell’ambito di questa più ampia riflessione, grande attenzione è stata attribuita alla rilevanza del lavoro psico-sociale, centrato su questa tipologia di migranti.
La dimensione dell’intervento psico-sociale, peraltro non nuova, ha assunto rilevanza perché tiene conto di due presupposti: le fragilità intrinseche alla tipologia di migranti a cui sono destinate le strutture per la prima accoglienza (persone in fuga da conflitti, persecuzioni politiche, minacce per la propria incolumità, carestie e disastri ambientali, con scarso patrimonio formativo e con un progetto migratorio indefinito, che affrontano un’avventura assai accidentata ed oltremodo perigliosa per raggiungere il paese d’arrivo, con tutto ciò che ne deriva anche in termini di rischi per la salute mentale) e la complessità degli ostacoli che questa tipologia di migranti si trova a dover affrontare sin dal momento del primo ingresso (disorientamento, difficoltà linguistiche, scarso patrimonio di risorse individuali e di capitale sociale disponibile nel nuovo contesto, gap culturale, intenso distress da trauma migratorio, incertezza in merito al proprio futuro, condizioni di vita all’interno di strutture spesso isolate dai centri urbani e quant’altro).
Il punto cruciale da cui scaturisce la rilevanza del lavoro psico-sociale è tuttavia il seguente: la possibilità di accedere ad una serie di opportunità che il sistema offre (assistenza legale, orientamento, opportunità formative, di mediazione, apprendimento della lingua ed inserimento sociale, lavorativo e persino abitativo) per queste persone non è automatica, né ovvia né, tantomeno, scontata. Come dire che non è verosimile attendersi che il semplice fatto di offrire l’accesso a queste opportunità sia sufficiente a garantirne la fruizione effettiva e sostanziale. A che ciò avvenga si frappongono numerosi ostacoli, in parte rappresentati dalle stessa condizione dei migranti (disorientamento, distress psicologico, barriera linguistica e quant’altro già ricordato) ed in parte riconducibili a difficoltà aggiuntive, ascrivibili ai lunghi tempi di attesa per il riconoscimento – o non riconoscimento – dello status, all’incertezza, alle condizioni di vita in contesti che a loro volta generano altri problemi legati alla vita collettiva, all’isolamento logistico con le conseguenti difficoltà di spostamento e quant’altro.
Vale ripeterlo ancora una volta: spesso le condizioni di vita all’interno delle strutture non favoriscono lo sviluppo di potenzialità positive ma, per molti versi paradossalmente, contribuiscono a “produrre patologia”. Tant’è che si può parlare di una sorta di “patologia iatrogena”, cioè di una condizione di malessere prodotta da un contesto che dovrebbe invece garantire attenzione e cure, cioè promozione del benessere.
In sintesi: lavoro psico-sociale significa sì offrire accoglienza ed opportunità ma significa – anche e soprattutto – accompagnare il migrante lungo i possibili percorsi che garantiscono l’accesso sostanziale alle opportunità offerte e, nondimeno, rimuovere gli ostacoli che a ciò si frappongono. Visto in questa luce, anche l’intervento psicologico non può essere considerato solo un segmento dell’insieme di azioni che il CAS mette a disposizione dei suoi ospiti, come segmento indipendente, attivabile a richiesta o laddove ritenuto opportuno. In tal modo l’intervento psicologico non si integra, o si integra poco, all’interno dell’intero insieme di azioni che configurano la presa in carico del migrante. Come dire che ciascun operatore – dunque ciascuna attività – non può semplicemente giustapporsi l’uno all’altro. L’intervento psicologico trova invece la sua più ampia espressione laddove è inteso come parte integrante, cioè integrata e non solo complementare, di un approccio multidisciplinare, che tende a considerare in maniera olistica il benessere psicosociale di queste persone. Ove ciò accada, il contributo dell’intervento psicologico attraversa l’organizzazione della struttura, gli stili di comunicazione e la stessa concezione dell’interazione tra i vari servizi ed attività di cui il migrante è destinatario e che hanno il migrante come loro centro. Anche il lavoro effettuato sui singoli casi tende a privilegiare una dimensione multidisciplinare, in modo che l’educatore si incontri con l’assistente sociale e con lo psicologo o l’insegnante di italiano, facendo sì che tutte le figure coinvolte possano scambiare le informazioni ed operare sinergicamente nella prospettiva di sostenere le risorse dei soggetti.
Dunque lavoro psico-sociale significa sostenere ed orientare costantemente ogni singola persona, rivedere e rinegoziare – tappa per tappa – il percorso che questa persona compie nell’accesso alle opportunità ed alle risorse rese disponibili. Percorso che certamente ha una natura “processuale”, cioè si sviluppa per gradi e comporta una concatenazione di servizi e di azioni, dipendenti gli uni dalle altre, volti a rispondere alle complesse esigenze di una presa in carico informata da un approccio “olistico”. L’accesso alle opportunità ed alle risorse rese disponbili si configura come percorso/processo di riformulazione – più spesso vera e propria costruzione – di un progetto migratorio, che sia coerente con le capacità del migrante, ovvero sostenibile, nella prospettiva di promuoverne l’autonomizzazione ed un positivo inserimento sociale, seppur con la spada di Damocle dell’esito del pronunciamento della Commissione.
Come in parte già accennato, tutto ciò comporta un fortissima integrazione tra la dimensione del lavoro psicologico e quella del lavoro sociale – del resto, lo stesso termine “psico-sociale”, nel trait d’union che lo caratterizza, rimanda a questa integrazione funzionale tra “saperi”, materiali e metodi, strumenti, luoghi e professionalità. Integrazione che nasce dalla verifica delle potenzialità, dall’individuazione delle risorse territoriali che siano coerenti con le potenzialità individuate, dalla capacità di sostenere la persona, orientarla, sostenerla nei momenti di frustrazione e di crisi, per evitare che perda le già limitate occasioni e via dicendo.
In un contesto ideale, la piena implementazione di questo modello implica un lavoro molto stretto di équipe (si parla infatti di équipes multidisciplinari) in modo da accertare la condizione inziale di ciascun migrante (si parla di screening) verificarne le caratteristiche e le potenzialità, individuare le opportunità disponibili nel territorio per selezionare, con un’operazione di matching, quelle che più si addicono al singolo profilo di migrante, per accompagnarlo e sostenerlo anche psicologicamente, ridefinendo gli obiettivi intermedi, ove necessario o nei principali punti di snodo del suo percorso.
Lavorare con i metodi e gli strumenti dell’intervento psico-sociale per dare concretezza agli obiettivi che realizzano la funzione del CAS
È chiaro che non si pretende qui di raccomandare la piena estrinsecazione del modello psico-sociale sopra descritta e già definita “ideale”, che al suo livello ottimale di funzionamento potrebbe non rivelarsi compatibile con le risorse al momento disponibili. Ma pur senza prevedere il raggiungimento dell’ideale, si ritiene possibile proporre qui alcune indicazioni migliorative, che riguardano il clima degli stili di lavoro, per favorire il raggiungimento degli obiettivi che il CAS, anche per contratto, ha il compito e la funzione istituzionale di perseguire. Sul punto si ritiene infatti che il CAS sia stato istituito con i seguenti obiettivi: fornire l’accoglienza di base, vigilare sullo stato di salute somatica e psichica, garantire un’assistenza legale, favorire l’apprendimento della lingua italiana e lo sviluppo dell’autonomia (ricostruzione di un progetto migratorio sostenibile ed orientamento) in modo che un eventuale pronunciamento favorevole da parte della Commissione esaminatrice possa consentire al migrante di dare rapidamente concretezza ad un percorso di positivo inserimento (integrazione) in Italia, oppure in modo che, in caso di pronunciamento sfavorevole da parte della Commissione, il migrante possa comunque affrontare il proprio futuro, fortificato da un’esperienza comunque positiva. Tendenzialmente, il migrante giunto in Italia, dopo esser transitato attraverso il CAS, dovrebbe uscirne arricchito nel proprio patrimonio e tale arricchimento dovrebbe consistere nell’aver acquisito una miglior conoscenza della lingua, nell’aver orientato e migliorato le proprie aspirazioni occupazionali e, ove possibile, aver anche incrementato il proprio capitale sociale.
Posto ciò, a titolo di esempio ed alla luce di quanto osservato ed ascoltato, si ritiene che, qualora si dovesse individuare un “indicatore sintetico” del lavoro che un CAS ha svolto nella direzione appena indicata, esso potrebbe rinvenirsi nel numero di ospiti che al termine della permanenza hanno acquisito un grado sufficiente di competenza linguistica.
Un esempio concreto: la familiarità con la lingua come indicatore sintetico di risultato
La questione dell’apprendimento della lingua italiana merita un approfondimento anche per il ruolo che quest’attività formativa svolge, dal punto di vista simbolico, oltre che pratico. Da quanto visto ed ascoltato si deduce che al momento, solo una quota assai esigua di migranti che attraversano i CAS riesce ad impegnarsi su questo versante. Questo dato rappresenta senza alcun dubbio un segno di sofferenza del CAS nell’adempiere adeguatamente al proprio mandato – per come descritto nel paragrafo precedente. Ma di fronte a questo dato è tuttavia opportuno chiedersi se il lavoro del CAS abbia creato le precondizioni – ed eventualmente quali – per agevolare l’acquisizione o l’incremento della competenza linguistica in italiano da parte dei propri ospiti. Per meglio chiarire il senso che a questa domanda qui s’intende attribuire, è lecito chiedersi il perché di questo chiaro segno di “disaffezione” del migrante nei confronti della lingua del paese che con tante difficoltà è riuscito a raggiungere e che gli offre assistenza. Ed è altresì lecito chiedersi quale intervento ha messo in campo il CAS per evitare l’innesco di questa disaffezione.
Nella maggior parte dei casi, anche per ovvie ragioni di praticità, coloro che accedono alle strutture di accoglienza ricevono e forniscono informazioni, cioè effettuano “scambi”, col ricorso a figure di mediatori linguistico culturali. Cioè continuano ad utilizzare la lingua d’origine – o lingue veicolari – come peraltro loro diritto, almeno per ciò che riguarda alcune procedure. Permane un dubbio sul fatto che lo scambio di comunicazioni in lingua d’origine o in lingua veicolare costituisca un passaggio sostanziale e non meramente o parzialmente formale. In altre parole, si vuole qui sollevare il dubbio che ciò possa avere anche una ricaduta disincentivante sui percorsi di integrazione (tenendo presente che la conoscenza della lingua è una delle dimensioni portanti dell’integrazione). E si vuole altresì ribadire che, oltre agli ovvi benefici pratici che la conoscenza dell’italiano garantisce al migrante, la lingua del paese d’arrivo dovrebbe rappresentare, dal punto di vista relazionale e simbolico, una via d’accesso e non già un ostacolo.
È noto che i CAS incontrano difficoltà ad avviare i migranti verso qualsiasi attività formativa, segno di una disabitudine del migrante (anche perché stressato e disorientato) a seguire iniziative di formazione strutturata. In particolare, la reticenza, se non il netto rifiuto, ad impegnarsi nel seguire i corsi di italiano, viene motivata dal fatto che le attività corsuali sono ritenute in molti casi inutili o comunque secondarie rispetto all’aspirazione a “voler subito lavorare”. Resta il fatto che la maggioranza degli ospiti delle strutture ne esce senza aver raggiunto livelli accettabili di competenza linguistica. L’apprendimento linguistico è solo un esempio, che parla di un rapporto disfunzionale con la permanenza nella struttura o, quanto meno, del facile innesco di forme di troppo debole coinvolgimento, bassa partecipazione emotiva, oltre che semplicemente cognitiva, in qualsiasi tra le attività che essa offre.
Come si può riuscire a comunicare col migrante e, attraverso la comunicazione, comunicargli anche la voglia di imparare l’italiano, per farne strumento prezioso ed indispensabile di scambio? Questa domanda per sottolineare che, sempre nell’ambito e nella logica del lavoro psico-sociale, l’efficienza e l’efficacia della comunicazione non è garantita solo dalla competenza linguistica in sé ma è garantita in primo luogo da alcuni elementi di contesto, appresso specificati, quali la costruzione di un setting comunicativo adeguato ed il trasferimento – esplicito o implicito – di un messaggio rassicurante sul significato e sul valore della lingua italiana.
In merito al primo punto, è opportuno garantire che il migrante acquisisca e comunichi le informazioni che lo riguardano in un contesto che abbia cura di non sottoporlo a forme di stress cognitivo, che incidono sia sulla capacità di apprendimento, sia su quella di raccontarsi.
In merito al secondo punto, è auspicabile che il migrante non guardi con ostilità alla lingua italiana, costruendo le premesse per favorire l’esperienza psicologica che l’italiano sia uno strumento di comunicazione e non una barriera. In altri termini: dar vita ad un percorso di scambio di comunicazioni, che aiuti gli ospiti della struttura ad instaurare un rapporto positivo con la lingua italiana, anche in considerazione del fatto che non sussiste un’effettiva pressione del fattore tempo (vista la non breve durata della permanenza) ai fini della reciproca acquisizione delle informazioni sostanziali. Il trasferimento delle informazioni può avvenire per tappe, lungo un percorso razionale, ovviamente da predisporre e costruire, inteso quale parte integrante del più ampio processo di presa in carico. Un percorso che, per passaggi successivi e consequenziali (ecco ancora un esempio della natura “processuale” della presa in carico psico-sociale) tenga conto delle variabili legate a: stile della comunicazione; rispetto dei tempi di apprendimento; predisposizione di “pacchetti” di comunicazione trasferiti progressivamente.
Ed è questa la luce in cui s’è prima detto che l’acquisizione della competenza linguistica in italiano potrebbe costituire una sorta di “indicatore sintetico di risultato”, cioè del buon funzionamento del lavoro della struttura, ovvero della capacità del CAS di raggiungere gli obiettivi per i quali è stato istituito. Indicatore sintetico perché indirettamente raccoglie in sé l’andamento di tanti aspetti a cui questo Report sta accennando, con lo stile del mostrare e dimostrare. Quest’indicatore dice che: si è partiti col piede giusto; vi è stato lo sviluppo di potenzialità positive; la permanenza nella struttura – parallelamente al decorso dell’iter burocratico della Commissione esaminatrice – ha contribuito a creare le premesse per un percorso di autonomizzazione; il migrante esce dalla struttura rafforzato dall’esperienza svolta, dal punto di vista cognitivo, relazionale e psicologico; l’intervento messo in campo nella struttura si è rivelato utile per “sagomare” il migrate (nel senso precedentemente indicato di “formare” ed “orientare”) attraverso la trasmissione di un serie di nozioni e capacità, sostenendolo adeguatamente.
La partita si gioca sul terreno della qualità delle relazioni
Il tema dello sviluppo delle competenze linguistiche è stato proposto come esempio per dire che, pur rinunciando alla prospettiva di raggiungere nei CAS il livello ottimale di funzionamento dell’intervento psico-sociale, è comunque possibile lavorare sul terreno della relazione e degli stili di comunicazione, per migliorare la capacità di queste strutture di conseguire, almeno in parte, i propri obiettivi fondamentali. In termini molto semplici, il CAS dovrebbe diventare: un ambiente che faciliti l’accesso del migrante alle opportunità che gli vengono offerte; un ambiente che faciliti il compito che il migrante in tal senso è chiamato a svolgere; un ambiente in grado di rimuovere gli ostacoli che a tale facilitazione si frappongono, cioè un ambiente in grado di prevenire l’innesco di meccanismi di disaffezione che tendono a passivizzare o rendere inerziale il migrante e, nel caso in cui tali meccanismi siano comunque in atto, sia in grado di introdurre interventi correttivi. Perché questi meccanismi non consentono al CAS di realizzare i propri obiettivi.
Lavorare sulla relazione e sugli stili di comunicazione significa che la relazione, cioè ogni forma e momento di interazione col migrante, dovrebbe essere improntata a dinamizzare le potenzialità di ogni persona ed evitare che essa si adagi in un’attesa magica ed illusoria (l’esito della richiesta presa in esame dalla Commissione) rinunciando ad rendersi protagonista delle attività che gli vengono proposte (attività formative, di apprendimento della lingua, di orientamento e quant’altro). Tutte le modalità relazionali e comunicative dovrebbero andare in questa direzione. Più in particolare: il CAS dovrebbe diventare il luogo ed il momento (la fase temporale della prima accoglienza) in cui matura una voglia di apprendimento che, in alcuni casi, non c’è.
È infatti importante tener presente che il lavoro del CAS interviene su una sorta di momento di passaggio che il migrante esperisce: momento anche emotivamente intenso, che segna il transito da una fase dominata dall’autosufficienza e dal continuo confronto con la pericolosità dell’avventura migratoria, verso una fase che invece configura una dimensione di protezione, necessità di affidarsi e costruzione di rapporti fiduciari. Il collocamento in un luogo sicuro – o presumibilmente tale – comunica l’uscita da una condizione di rischio, dunque il passaggio dalla dimensione “dell’Io” (posso contare solo su me stesso per la mia esistenza ed il mio futuro) a quella “del Noi” (posso condividere la responsabilità della mia vita e di ciò che voglio e posso farne). Certamente, in questa fase è facile la deriva su posizioni dominate sia dalla diffidenza, sia dalla delega passiva – sorta di reazione negativa di transfert e controtransfert tra il migrante e la struttura o, come già detto, segno di disreattività tra migrante e struttura – che, una volta consolidate, sono difficili da modificare. La modalità relazionale che informa sin da subito il rapporto col migrante costruisce nella sua mente un’immagine della struttura stessa – e per molti versi un’immagine complessiva del contesto d’arrivo – che nel tempo successivo sarà sempre più complesso trasformare. Ecco perché è fondamentale pensare a come gestire adeguatamente questa cruciale fase di passaggio che il migrante si trova ad attraversare, con riguardo a come – in questa fase di passaggio, che costituisce un vero e proprio punto nodale per l’ulteriore sviluppo del suo cammino migratorio – l’incontro con la struttura e la vita al suo interno possano “sagomarlo”.
Per tornare ancora sull’esempio dello sviluppo della competenza linguistica ed al di là dell’avvio del migrante verso le attività corsuali – corsi strutturati di insegnamento dell’italiano come seconda lingua che certamente non sono di competenza del CAS ma degli enti a ciò preposti, coi quali tuttavia il CAS deve operare secondo le logiche del “lavoro di rete” – s’è detto che si può favorire in tutte le occasioni l’uso dell’italiano come lingua di comunicazione e di scambio (limitando all’indispensabile il ricorso ai dispositivi di mediazione) a patto di consentire i tempi di comprensione e di lavorare sulle modalità attraverso le quali gli operatori parlano con gli ospiti della struttura, per individuare – per errori e per tentativi – quelle più consone. Certamente questo lavoro sugli stili di comunicazione discende da una riflessione, individuale e condivisa dal gruppo di operatori, piuttosto che dalla semplice codificazione di ciò che si deve fare e di ciò che è proibito fare, peraltro impossibile da realizzarsi.
La capacità di favorire in tutte le occasioni l’uso dell’italiano non è cosa di poco conto, perché non solo favorisce la familiarizzazione con la lingua ma, fatto ancor più rilevante, impedisce che il migranti si adagi nell’abitudine all’estraneità all’italiano, o peggio nella convinzione che – per lui – sia impossibile apprenderlo. Dall’italiano alla formazione ed all’orientamento, ogni occasione di apprendimento deve configurarsi come tale nella mente del migrante: anche spiegare come si va in città ed a quale indirizzo ci si deve rivolgere per disbrigare una qualsiasi incombenza offre l’opportunità per dar luogo ad un’occasione formale di apprendimento, che per gradi e cumulativamente via via predispone il migrante – come dire che lo abitua – ad affrontare momenti formali di apprendimento, fino a star seduto in un’aula (ove necessario) per imparare qualcosa.
Si potrebbe obiettare che il CAS incontra uomini e non già “bambini”, ovvero che un’eccessiva “infantilizzazione” di queste persone comporta anch’essa un rischio. In proposito si può dire che sappiamo bene che non si tratta di “bambini”, visto che non è propriamente impresa da “bambini” quella di partire dall’Africa sub-sahariana (ad esempio) percorrere una strada lunga ed incerta che conduce a stazionare, tra mille pericoli, sulle coste del Mediterraneo in attesa di attraversarlo, rischiando seriamente la vita, per giungere in Italia. Ma queste persone, che seppur poco scolarizzate, dispongono certamente di capacità di non poco conto, dopo esser state accolte e “ristorate”, anche nel senso indicato dal mito dei Feaci, hanno comunque bisogno di esser guidate, in un clima relazionale favorevole, anche per mettere a frutto le loro capacità.
Un altro esempio concreto: il lavoro sulla relazione e sugli stili di comunicazione nella fase del primo ingresso del migrante nel CAS
Alcune indicazioni su come lavorare nella fase del primo ingresso nel migrante nel CAS sono sia un esempio a cui fare riferimento nello svolgimento degli interventi successivi, sia un ulteriore richiamo all’importanza di questo momento iniziale, o di esordio, che come già più volte ricordato assume un significato quasi rituale, perché segna un passaggio, è può realmente costituire, per il migrante, il primo accesso ad un altro mondo, cioè ad una nuova dimensione psicologica, linguistica, esistenziale. Dimensione caratterizzata da un’attitudine mentale che, se progressivamente acquisita, dovrebbe poi facilitare le attivazioni successive.
Il racconto degli operatori e le visite nelle strutture segnalano che l’ingresso del migrante si verifica in un clima generalmente concitato, in cui domina la preoccupazione del personale del CAS di registrare gli ospiti e fornire loro una serie di informazioni (sorta di “pacchetto” di ragguagli, chiarimenti e spiegazioni che sono giustamente ritenuti indispensabili). In sintesi, si è avuta l’impressione che gli operatori avvertano la necessità di un tempo contingentato per il trasferimento di queste informazioni, anche perché sono consapevoli dell’importanza dell’azione di informare correttamente (ad esempio nei termini: “è fondamentale che tu capisca quello che ti verrà detto, se non capisci rischi di compromettere il tuo destino”). Ma questa pur comprensibile consapevolezza esita talvolta in una sorta di sollecitazione minacciosa, cioè in uno stile comunicativo che rischia di produrre anche uno stress cognitivo nel migrante e paradossalmente ostacola la comprensione, producendo – o acuendo – invece i livelli d’ansia, visto anche il clima concitato.
Come già segnalato, la modalità di comunicazione è quasi sempre contraddistinta dall’uso della lingua d’orine o di lingue veicolari, con l’intervento del mediatore.
In questo tempo contingentato in cui avviene il trasferimento delle informazioni, il migrante è principalmente “oggetto” di comunicazioni, più o meno formali, mentre minor attenzione e spazio vengono dedicati alla registrazione di ciò che accade nella mente – o nella percezione – del migrante. Ovvero pochi elementi conoscitivi o nessun elemento conoscitivo vengono registrati – o comunque acquisiti – nella prospettiva di costruire un percorso di presa in carico, ovvero traguardando la prospettiva di predisporre un progetto individualizzato.
Gli operatori segnalano altresì che sovente i migranti mostrano loro di non avere facile accesso sostanziale alle informazioni e sviluppano una sorta di reazione di tipo ansioso rispetto a ciò che hanno effettivamente capito o non capito, anche attivando ritualità rassicurative, come nel caso assai frequente in cui reiterano giorno dopo giorno le medesime richieste di informazioni all’operatore.
Certo è che in questa fase iniziale si verifica una sorta di attivazione psicologica molto intensa del migrante, che corrisponde ad un’accelerazione del tempo mentale, a cui però fa seguito, col passare dei giorni, una dilatazione del tempo, perché la giornata si svuota.
Posto ciò, è possibile dire che, nella fase di primo ingresso, il trasferimento delle informazioni dovrebbe essere organizzato in modo da diventare parte di un rituale definito di accoglienza, che potrebbe prender le mosse, ad esempio, da un momento iniziale “di benvenuto” e sia caratterizzato da un clima meno dominato dall’urgenza. Al fine di informare correttamente, è opportuno prevedere lo “spacchettamento” dell’insieme di informazioni da trasferire, suddividendolo in più unità, che senza esitazione si possono qui definire “didattiche”. Perché ciascuna unità può essere “somministrata” (cioè impartita proprio secondo i metodi, gli strumenti e lo stile della didattica) in condizioni di formalità educativa, anche con una verifica dei livelli di comprensione, prima di passare all’unità successiva. Allo stesso modo (come già descritto nel paragrafo dedicato all’esempio dell’apprendimento della lingua) il contesto relazionale in cui avviene il trasferimento progressivo delle informazioni sarà predisposto in modo da non sottoporre il migrante a forme di stress cognitivo, che incidono sia sulla capacità di apprendimento.
Lo “spacchettamento” delle informazioni in più unità dovrebbe altresì consentire di cominciare ad impartirle anche in lingua italiana, in base alle indicazioni già prima proposte, cioè rispettando i tempi di apprendimento ed in modo da abituare ed orientare tutte le forme di interazione tra il migrante e la struttura sempre privilegiando l’uso dell’italiano, così da stimolare precocemente i percorsi successivi. Questo stile di lavoro consente agli operatori che trasferiscono le singole unità informative di acquisire e raccogliere una serie di conoscenze in merito a: modalità reattive del singolo migrante, attitudine ad interagire con l’interlocutore, livelli di alfabetizzazione e formazione, capacità di elaborare le informazioni ricevute, capacità di assumere compiti e modalità di sviluppare ansia nell’assumere o svolgere un compito. Queste conoscenze iniziali sono preziose perché rappresentano primi indicatori, di cui il CAS dispone per impostare le successive fasi di orientamento del migrante verso un percorso di lavoro sull’ansia, che a sua volta preceda l’inserimento in altre attività, in modo da evitare che l’avvio di altre attività, tra quelle che il CAS rende disponibili (formazione e quant’altro) esitino in scacchi, frustrazioni, fraintendimenti e tensioni con gli operatori. In sintesi: utilizzare questa prima fase di ingresso, che prevede il trasferimento delle informazioni, anche come tempo di osservazione, che possa poi condurre ad un più ragionato inserimento del migrante nelle attività che si possono realizzare nel CAS o attraverso il CAS. Anche nella logica per cui l’offerta di varie opportunità attivabili possa rientrare in una progettualità temporale, alla quale i migranti vanno sostanzialmente ri-abituati.
Qui si vede bene, ancora una volta, cosa vuol dire pensare in termini di lavoro psico-sociale, inteso come integrazione (e non già semplice giustapposizione) tra le varie attività e professionalità. Vuol dire pensare che lo stile di lavoro e le prassi stabilite sono sempre finalizzate non già ad una risposta consuetudinaria mossa dall’urgenza, bensì nel rispetto delle persone accolte.
Ultimo spot su équipes multidisciplinari e costruzione di un “ambiente facilitante”
Costruire all’interno dei CAS un ambiente che non si limiti alla mera erogazione di una serie di attività e di servizi ma promuova quel benessere psicosociale sul quale tanta letteratura ha da tempo posto l’accento significa articolare le numerose attività in cui il migrante viene inserito, in modo da non produrre la “sensazione del tempo che si svuota”. Con riguardo specificamente all’intervento psicologico, esso svolge la funzione di garantire un sostegno non solo quando l’eventuale disagio si manifesta, bensì in ogni momento in cui si presentino difficoltà a sostenere lo svolgimento delle attività. Il senso ultimo del lavoro psicosociale risiede nell’opportunità di “riempire” la durata della permanenza del migrante nella struttura, con attività che gettino le premesse di un possibile progetto migratorio – ovvero di progressiva autonomizzazione – ed accompagnino lo sviluppo di tale progetto in modo che esso corra parallelamente al decorso dell’iter burocratico della Commissione esaminatrice. In ogni caso ed a prescindere dall’esito della pratica di riconoscimento dello status, ciascun migrante dovrebbe uscire dalla struttura di accoglienza rafforzato dall’esperienza svolta durante la permanenza al suo interno. Rafforzato dal punto di vista relazionale, psicologico, della competenza linguistica in italiano e quant’altro.
Tutti sanno che la programmazione è complessa e – vale ripeterlo – non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, anche alla luce degli esempi citati, vi sono alcuni principi per transitare verso un modello alternativo, più vicino allo stile del lavoro psicosociale: far sì che ciascun segmento di attività sia concepito come parte di un processo complessivo di presa in carico; evitare l’innesco di condizioni “iatrogene”, legate ad una sorta di esecuzione formale dell’attività, senza soffermarsi sulla sua efficacia (è il caso dell’operatore che trasferisce le informazioni perché è suo dovere ma, anche per ragioni riconducibili alle pressioni di un clima di costante emergenza o ad altri comprensibili motivi, non riesce a considerare se la modalità che segue è la migliore ai fini del percorso complessivo del migrante); prestare attenzione alla prevalenza dell’accoglienza, quale fattore incentivante la sostenibilità dei compiti che gli ospiti della struttura dovranno affrontare; prediligere il lavoro multidisciplinare, affinché le varie figure professionali, nel corso dell’interazione, inizino a profilare il soggetto, per capire quale può essere il percorso ipotizzabile per ogni singolo utente.
L’enfasi sin qui posta sulla rilevanza della familiarizzazione con la lingua italiana (fino ad intravedere in questo aspetto un indicatore “sintetico”) e sugli stili di comunicazione ha altresì il senso di richiamare l’attenzione, attraverso esempi concreti, sul lavoro multidisciplinare, finalizzato alla costruzione di un “ambiente facilitante”. Il lavoro del CAS e nel CAS è generalmente svolto da un’équipe multidisciplinare, composta – come peraltro prescritto dai bandi – da un insieme integrato di figure, “saperi” e professioni: assistente sociale, educatore, consulente legale, psicologo, insegnante di lingua e mediatore. Tramite il lavoro di équipe, che certamente va rafforzato, s’intende superare la logica dell’utilizzo a chiamata delle varie figure (modello della semplice giustapposizione degli interventi) a favore invece di un lavoro congiunto ed integrato, svolto per l’appunto da un’équipe (secondo il modello dell’intervento psicosociale) il cui senso ultimo risiede nella capacità di costruire un “ambiente facilitante”. Dunque: conferire al CAS la caratteristica primaria di porsi come luogo in grado di facilitare il migrante nell’accesso alle opportunità che gli possono venir offerte.
Facilitare vuol dire per un verso individuare le opportunità disponibili nel territorio, ovvero sollecitare il territorio a mobilizzare tutte le risorse attivabili, secondo le modalità del “lavoro di rete”. Per un altro verso e nel contempo, facilitare vuol dire costruire le premesse, ovvero le precondizioni, per cui il migrante sia messo in grado di cogliere le opportunità che il territorio fornisce o dovrebbe attrezzarsi a fornire. Premesse e precondizioni che certamente spaziano da quelle meramente logistiche a quelle più inerenti il piano motivazionale.
E sul punto torna utile un richiamo all’esempio concreto della familiarizzazione con la lingua italiana. Al di là della presenza di un insegnante di italiano all’interno dell’équipe multidisciplinare (che svolge una diversa funzione) non è certo compito degli operatori del CAS realizzare corsi di italiano come seconda lingua, perché a ciò sono specificamente preposti gli enti territorialmente competenti. Il lavoro di facilitazione che invece il CAS è precipuamente chiamato a svolgere, di cui il CAS deve sentirsi soggetto pienamente responsabile e sul quale si richiede il massimo sforzo, consiste invece nel costruire tutte le condizioni affinché il migrante sia invogliato ad apprendere la lingua (ecco la facilitazione sul piano della spinta motivazionale) e sia posto in condizione di poterlo fare (ecco la facilitazione dal punto di vista logistico che dovrebbe consentire ad esempio al migrante di potersi recare quotidianamente e senza difficoltà insormontabili presso i centri che forniscono corsi di lingua). Nella cosiddetta “facilitazione” risiede la funzione preminente del CAS, proprio perché il CAS è la struttura che più di ogni altra ha a che fare col migrante, in maniera stabile e continuativa, finché lo ospita.
Dunque non si chiede agli operatori del CAS di farsi vicari di soggetti specificamente deputati a svolgere determinati compiti, né tantomeno di sostituirsi ad essi ma di rendersi sempre più protagonisti del loro ruolo di “costruire i presupposti per …”.
Si può in conclusione dire che l’impostazione della fase di accoglienza prevede complessivamente una riflessione su come dare coerenza all’aspetto meramente organizzativo dell’ingresso delle persone nella struttura e del trasferimento ad esse delle informazioni necessarie a trascorrere al loro interno un periodo della loro vita. Si parla della definizione delle informazioni di tipo legale relative alla condizione di migranti, unitamente a quelle che sono necessarie a definire il percorso nei confronti della Commissione che esamina le loro richieste. Vi è nel contempo una riflessione intorno a come effettuare una valutazione, da parte dello staff, di quelle che possono essere le modalità relazionali anche rispetto agli obbiettivi che per ciascun ospite ci si prefigge di raggiungere, ovvero rispetto al percorso che ciascun migrante deve compiere. Si tratta di una valutazione che è anche psicologica, con riguardo al benessere complessivo del migrante e rispetto alle modalità di apprendimento, cioè di comprensione partecipata del percorso che lo attende. Il tutto dev’essere poi inserito all’interno di una sorta di “proceduralizzazione”, che vede un costante confronto tra tutti i componenti del gruppo di lavoro, per verificare se le informazioni sono giunte, se sono state recepite e se sono state recepite correttamente, nonché per capire se qualche informazione torna utile a definire le modalità di presa in carico, la progettazione dell’intervento da effettuare e delle tappe lungo le quali costruire ed articolare questo percorso informativo e formativo, unitamente agli obiettivi da definire e raggiungere progressivamente (come già detto, lungo un percorso che ha natura “processuale”). Detto in altri termini: si tratta di valorizzare gli elementi raccolti (le informazioni sul migrante) per strutturare le tappe di una sorta di percorso evolutivo, operando una scansione temporale, in modo da aiutare il migrante a comprendere che ad una tappa ne seguirà un’altra e che, tappa per tappa, il migrante stesso acquisirà la capacità di progettare una propria traiettoria di vita. Ed è per l’appunto questo il senso del “lavorare in équipe multidisciplinare” che sostanzialmente è stato rilevato nel corso delle osservazioni condotte e nel corso dell’ascolto degli operatori. Come dire che, seppur in maniera non sempre strutturata e non così organizzata mentalmente, è questa la modalità di lavoro che nei CAS si tenta di svolgere.
Posto ciò, si può qui aggiungere che è opportuno precisare la prospettiva in cui il lavoro di équipe, così inteso, si debba porre. In sintesi, la prospettiva consiste nel far sì che il tempo di permanenza nel CAS sia uno spazio facilitante e nel far sì che il CAS stesso sia un luogo facilitante. Torna la domanda già posta prima: per facilitare che cosa? In questa prospettiva, il CAS è un luogo facilitante nella misura in cui si costituisce come luogo di protezione e sicurezza, ovvero è facilitante nella misura in cui facilita la percezione della sicurezza. È anche facilitante perché dovrebbe essere un luogo di sperimentazione di percorsi ed opportunità, in un clima di non violenza e non discriminazione. Ed è altresì facilitante perché fornisce al migrante che ospita gli elementi necessari a ritessere e ricostruire una progettualità che tende a portarlo fuori dal CAS, fuori dalla struttura di accoglienza ed emergenza, offrendogli la possibilità di individuare una traiettoria temporale di vita. Vale soffermarsi ancora su questo punto perché, per l’appunto per le ragioni appena dette, il CAS dovrebbe sostenere il migrante e motivarlo a trovare e costruire una propria traiettoria al di fuori del CAS stesso, in modo da far sì che il migrante non rimanga come “intrappolato” all’interno del CAS. In questo modo, il migrante non vede – e non deve vedere – nel CAS lo strumento di soluzione dei propri problemi, bensì vede nel CAS il luogo di facilitazione per trovare o ritrovare le risorse che gli consentono di confrontarsi con i propri problemi. Risorse che dunque dovranno esser “pescate” dal migrante nel territorio, ovvero nelle reti territoriali che sempre il CAS avrà provveduto a costruire o attivare.
Acquisire la logica e la prospettiva della “facilitazione”, da parte del CAS, significa che il CAS pensa se stesso – e di conseguenza costruisce se stesso – come un ponte tra il migrante ospite ed i servizi e le strutture territoriali che più propriamente possono svolgere le principali funzioni a favore dei migranti. È chiaro che idealmente, in accordo peraltro con l’ipotesi dell’accoglienza diffusa, si dovrebbe immaginare una progressiva “dissoluzione” del CAS (che non solo è struttura di permanenza temporanea dei migranti ma rappresenta al tempo stesso una struttura temporanea in sé, cioè volatile ed effimera) mano a mano che il territorio, nella sua capacità di accogliere, sarà in grado di assicurare un’immediata integrazione di queste persone. Tuttavia, poiché come ben noto quest’ipotesi ideale, ancorché realistica ed auspicabile, resta al momento ed almeno parzialmente difficile da realizzare, il CAS deve ancora sviluppare e garantire questa sua funzione di accoglienza, attraverso la costruzione di ponti con gli attori istituzionali che sono preposti a svolgere alcuni dei servizi a sostegno dell’immigrazione (ad esempio: i CIPIA, le ASL i Centri per l’impiego e quant’altro) in modo che, rapidamente o lentamente a seconda dei casi, il migrante cominci a muoversi nel territorio avendo i suoi “punti di repere” e la sua capacità di autonomia.
Precisato dunque il senso del lavoro facilitante, alla luce di quanto osservato ed ascoltato, per un verso costituisce facile motivo di preoccupazione notare che non sempre il CAS riesce a porsi come luogo sicuro e non discriminante; che non sempre il CAS riesce a fornire opportunità di orientamento ed autonomizzazione, determinando nel migrante la sensazione dello “svuotamento del tempo”. Ma per un altro verso costituisce motivo di altrettanta apprensione il rilevare che il CAS rischia spesso di restare una sorta di isola autonoma, in cui il soggetto tende a rimanere come incastrato. È chiaro che alcune iniziative non si posso realizzare, se non con difficoltà (ad esempio momenti di aggregazione ed occasioni di costruzione di reti di capitale sociale, che pure in alcuni casi ed alcuni contesti sono state messe in campo) e nemmeno si può immaginare che dappertutto sia possibile organizzare tutto ma sempre è immaginabile che la relazione con i soggetti istituzionalmente preposti a svolgere alcune funzioni essenziali in questa fase dell’accoglienza possa essere adeguatamente attivata. In questa luce sono stati qui ricordati gli esempi della scuola, dei CIPIA dei Centri per l’Impiego e quant’altro. Per ricordare l’importanza di un’azione di raccordo che dev’essere necessariamente potenziata, avviata o pensata, fin da subito, dai CAS e nei CAS.
Per Approfondimenti:
Accordo di collaborazione tra Associazione Culturale Acuarinto e IPRS
Progetto SESAMO: servizi di salute mentale per richiedenti e titolari di protezione internazionale